Questo pezzo nasce da una constatazione, un’ovvietà, lo riconosco, ma è qualcosa che mi fa prudere le dita sulla tastiera e che ha bisogno di macchiarsi di nero sul bianco del foglio. Mi hanno sempre insegnato che uno scrittore deve saper scrivere, il cantante cantare e che la modella deve avere un “personale” – come direbbe mia nonna – adeguato alla professione. Ma non sempre funziona così.
Se hai seguito o se ti sei creato una community, grazie ai social, puoi magicamente pubblicare libri o dischi, scalando le classifiche grazie a una strategica attività di marketing. Non ti preoccupare se non sai scrivere, ci sono i ghostwriter. Non preoccuparti se non sai cantare, la tecnologia fa miracoli. Vuoi fare la modella? Photoshop è uno dei migliori alleati per aiutarti ad eliminare inestetismi di ogni sorta, meglio dei fanghi o delle sudatissime sedute di cross fit.
Insomma, se manca una competenza, non c’è bisogno di acquisirla, quando ci sono altri che ti cedono la propria. Facile, no?
Certo, tu hai l’abilità di attirare e calamitare su di te l’attenzione di molte persone, cosa che magari i tuoi “prestatori d’arte” non sono mai riusciti a fare. Quindi tu rimani in bella mostra, e loro ti coprono le spalle. Fin qui, niente di nuovo.
Il problema, perché per me adesso lo sta diventando, è che chiunque pensa di poter fare e dire tutto. So di essere impopolare, ma forse aveva ragione Eco: «I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli».
Non per essere snob, ma questa cultura del fake travestito da reale supera il paradosso di “Westworld”, tanto che forse gli umanoidi riusciranno a essere sostanzialmente più di valore di un individuo qualunque. O comunque, meno superficiali.
Allevamenti intensivi di follower, like, commenti, view e qualunque cosa si riassuma in un: “guarda quanto sono popolare!” si diffondono come metriche di riferimento anche grazie ai media generalisti che alimentano l’esposizione tossica dell’essere.
Difendere la propria fragile autostima dal manto dell’indifferenza è diventato lo sport nazionale di molte star del web, che non mancano di condividere qualsiasi cosa, in ogni modo e maniera, purché se ne parli, si condivida e si commenti.
Lode e pregio a chi non inquina ma sa fertilizzare il web con un po’ di cultura e qualità. Però, diciamocelo, il trash attira più del miele ed è specchio di una società, del tutto e subito, dell’instant win delle gratificazioni, dei ragazzi che ti dicono che da grandi vogliono fare l’influencer, non importa quale sia l’ambito, ma quanti soldi, fama e approvazione degli altri si riescono a conquistare.
La sagra del “non è tutto oro quello che luccica” svela retroscena piuttosto tristi: aziende che si autofinanziano il crowdfunding, autori che si auto comprano il proprio libro per scalare le classifiche di Amazon, acquisto compulsivo di visualizzazioni su You Tube e qualunque cosa faccia apparire di avere una corte al seguito.
È tutto così facile e a portata di mano che chi fa le cose in modo etico passa per uno che non ci capisce niente. Un po’ come il secchione che veniva deriso dai compagni perché lui sprecava il tempo a studiare mentre gli altri si godevano la vita.
Qualche giorno fa, sul treno, ho intercettato una conversazione tra esponenti della generazione z: un panegirico sull’addominale scolpito, i Rolex e roba che chi ascolta la musica trap conosce a menadito. Per loro l’università è da sfigati perché “si fanno più soldi con i placement“. Ma davvero i brand credono che far fare i placement – come dicono loro – a questi “influencer” dal congiuntivo che fa acqua più di una congiuntivite, agevoli il proprio posizionamento? Che tipo di valore e di sostanza riescono a (r)aggiungere?
Domanda retorica, lo so: loro producono quello che vuole la sempre più vasta (e finta) community che li segue.









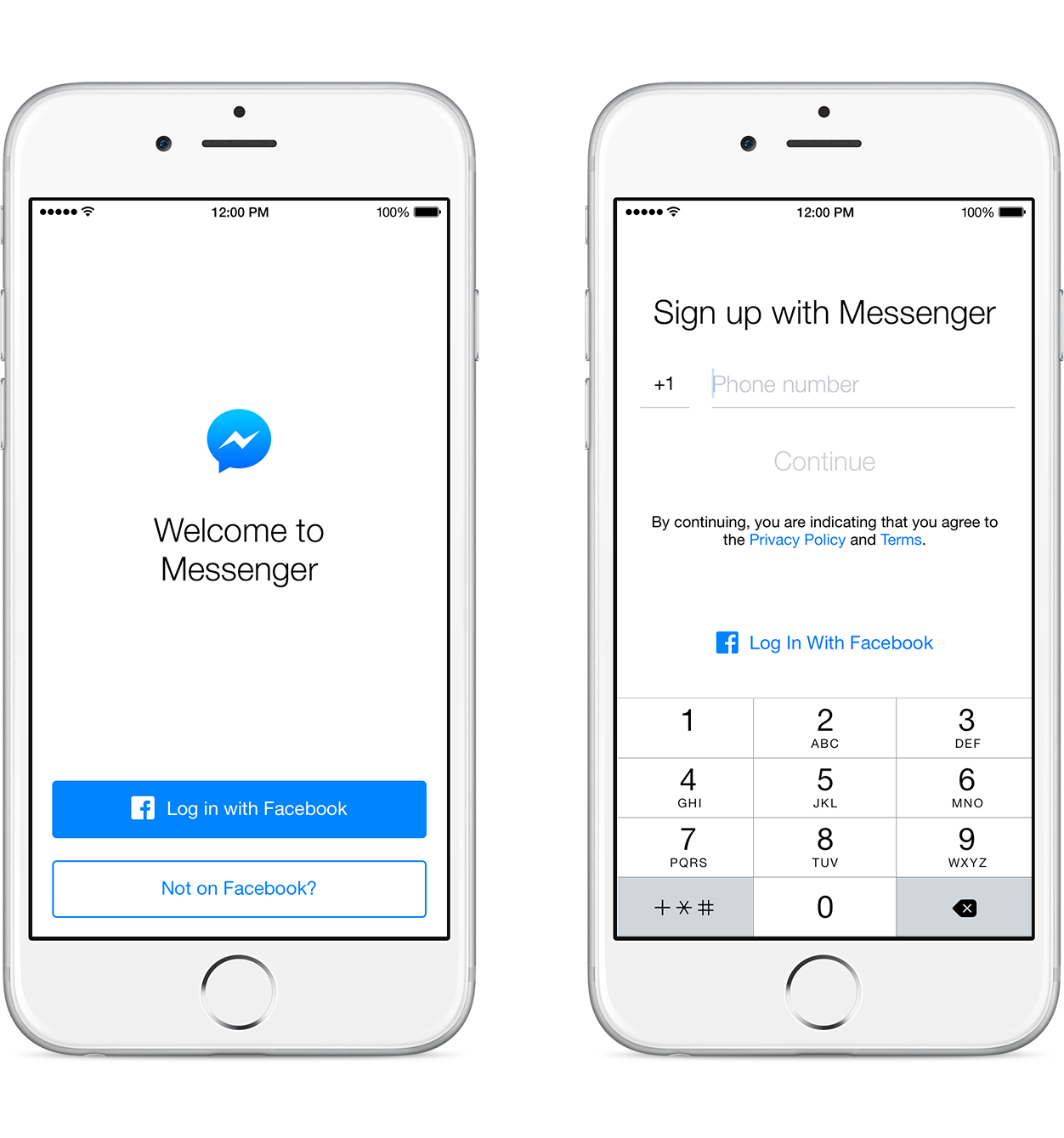
Facebook Comments