Più volte abbiamo sottolineato quanto l’essere nativi digitali non metta i ragazzi automaticamente al riparo da quello a cui si può andare incontro in Rete e che, pertanto, debbano essere i genitori (come per ogni aspetto della vita del resto) a fare da guida.
Abbiamo anche evidenziato quanto sia utile per gli stessi un’adeguata informazione (e, perché no –vista la vastità dell’argomento-, anche una vera e propria formazione) in tal senso.
Quando all’università mi suggerirono di aprire un profilo Twitter, mi dissero che avrei potuto costruire il mio personal branding. E per farlo, non avrei dovuto certo denigrare la gente con il solo scopo di accreditare la mia immagine presso gli altri.
Vi immaginate se a commettere atti scorretti di questo tipo, invece di essere un ragazzino, fosse un genitore? Quest’ultimo, come potrebbe essere una guida per il figlio? Eppure tutti sentono parlare di questi argomenti in giro. Ma si ritorna sempre al solito punto: c’è una differenza importante tra il “sentito dire” e la “piena consapevolezza”. E questo vale anche per mamme e papà che non sono esperti –propriamente intesi- di Internet.
Non molti mesi fa, in Rete è scoppiata una polemica perché una donna, per mettere in risalto la buona riuscita (grazie all’utilizzo di integratori di cui era venditrice, per poi essere licenziata in seguito all’accaduto) del suo percorso dimagrante, ha postato una foto in cui si vedevano delle mamme, sicuramente più robuste di lei, commentando che, proprio per la loro “condizione”, i mariti guardassero le altre. Non sono mancati, sotto il suo post, commenti di approvazione dalle colleghe, ma anche di sdegno. Lla donna si è poi scusata.
Se dovesse capitare al figlio, oggi potrebbe insegnargli che non si fa, ma questo perché lo ha imparato a spese di altre persone. Nemmeno l’essere adulti ci fa stare in una botte di ferro, così andiamo a inciampare persino in argomenti delicati come la fisicità delle persone (come in questo caso), perché si deve rientrare in determinati canoni imposti dalla società, altrimenti tra noi e la gogna pubblica è un attimo. Infatti, potresti anche essere super magro, poco importa, avrai altri difetti che non rispondono ai canoni, meritevoli di essere enfatizzati al punto di superare il labile confine tra una presa in giro innocua e il cyber-bullismo. Che ci vuole? Basta premere il tasto sharing! Eppure…
Siamo figli diversi una sola memoria, che disegna e cancella distratta la stessa storia (cit)
Siamo figli di mondi diversi una sola memoria: l’ambiente; che disegna e cancella distratta la stessa storia: la società.
Crescendo l’individuo smette di essere un “io” per diventare un “noi”. Entra così in gioco l’Alterità, di cui la società rappresenta la più alta espressione, ma che non tiene conto del vero essere dell’individuo, quel sé non relazionale, l’Altro rappresentato dalla società diventa una vera e propria relazione. Ma l’esperienza vissuta nella prima fase non viene rimossa, tutt’altro, resta impressa nella mente a livello inconscio, tanto da portare allo sviluppo di una forma di narcisismo, in quanto non ci si può certo dimenticare di essere appartenuti alla vita (l’ambiente) e di avervi rinunciato per diventare degli esseri sociali (è nella fase onirica che si ritrova se stessi, ritornando in contatto con la vera unicità).
Nella società non c’è attaccamento, ma relazione. Esso esiste solo in riferimento alla vita e all’ambiente che sono per natura coincidenti, ma non per quanto riguarda la società; essa infatti non può coincidere con la vita, dato che non sono fatte della stessa sostanza.
E’ grazie al processo educativo che l’individuo interiorizza le norme sociali, facendole proprie. Da essere manchevole, vuoto, privo di istinti (come lo definisce Gehlen), viene quindi “riempito”, diventando qualcosa che è altro da sé. E persino le esperienze che, vissute in solitudine nell’ambiente sono positive, per la società non lo sono affatto, tant’è che la solitudine viene considerata una patologia.
L’etimologia della parola significa “essere unico”, ma se il soggetto rimanesse tale, sicuramente non potrebbe essere plasmato a immagine e somiglianza della società. E ciò rappresenterebbe un problema, perché essa non ci vuole unici, bensì tutti uguali.
Quanto più il bambino crescendo riuscirà ad interiorizzare al meglio quei modelli culturali, tanto più potrà aspirare a diventare quell’uomo ideale ed essere accettato; diversamente sarà al massimo tollerato, ma non di certo amato.
Per poter “riempire” questo bambino, il processo educativo ricorre all’uso del linguaggio simbolico, quindi della parola, la quale va a sostituire gli istinti o, come direbbe Gehlen, a correggerli; egli infatti, definisce il processo di socializzazione un processo di correzione o disciplina, proprio in ragione del fatto che, per la società, la vita appaia come un problema e vada quindi corretta.
Viene addirittura vista come la prima forma di devianza in quanto, alla nascita, non ne esiste nessuna perfettamente conforme ai modelli socio-culturali e per questo, occorre “creare” – come dice il Prof. Stauder – degli individui completamente assoggettati all’ordine sociale. A tal punto da diventare prolungamento della società stessa (esseri sociali, come li definisce Durkheim) e arrivare a non riconoscere più se stessi se separati da quest’ultima.
Deve avvenire ciò che gli psicologi definiscono “eclissi del corpo”, che porta l’individuo alla rimozione del vero sé che, nell’età adulta, vive sotto forma di ricordi.
Ma dobbiamo ricordare che – come ci insegna la filosofia tedesca – se si strappa qualcosa alla natura e la si trasforma senza restituirla alla natura stessa, si sta commettendo un atto di violenza, ed è proprio ciò che avviene all’individuo quando diventa un essere sociale. La natura, al contrario, se pure consuma qualcosa per il suo mantenimento, non la sta distruggendo, perché rimane comunque a disposizione della natura stessa. All’uomo purtroppo, una volta socializzato, non resta che rifarsi sempre e soltanto a quei valori per non essere considerato un deviante.
Ma tutto ciò, potrebbe sembrare quasi un paradosso se si pensa al fatto che la società vive solo attraverso gli individui e che, se si estinguesse nelle loro menti, cesserebbe di esistere.
La soluzione auspicabile per l’antropologia sarebbe quella di trovare una società-ambiente che accolga l’individuo, preservando la sua specificità, quindi unicità. Ma parrebbe una concezione forse ai limiti dell’utopia se si pensa che la società vuole l’esatto opposto, cioè oscurare tutta la vita pre-sociale dell’uomo, e questo per un solo motivo: perché se il vissuto non venisse rimosso non potrebbe conformarsi integralmente alle norme esterne, e tenderebbe perciò a rimanere attaccato all’ambiente dove c’è la vera vita, quella non costruita socialmente.
In fondo l’uomo cosa fa quando vede per qualche motivo i valori sociali in cui crede entrare in crisi?
Cerca nuovamente il contatto con se stesso, con quell’ambiente che lo proteggeva da bambino, in cui era un essere unico, mai messo in discussione, perché là era egli stesso ad essere tutta la vita (da qui il narcisismo di cui parlavamo); in cui la solitudine esaltava il vero sé, prima che la società lo costringesse ad indossare una maschera per diventare “persona”, pronta a salire sul palcoscenico della sua stessa esistenza, nell’attesa di ricevere un encomio per la migliore interpretazione, o forse finzione, poco importa. Tanto gli stessi che lo applaudiranno riconoscendo il suo status sociale, saranno gli stessi che si sono auto-imposti di interpretare lo stesso ruolo, gli stessi che lo costringono a fuggire “dietro le quinte”, mandandolo in crisi.
Ma se è lì che vive e vivrà sempre l’io autentico, non è forse un bene che questi spettatori e al contempo attori dei ruoli sociali, facciano entrare più spesso in crisi i valori a cui essi stessi hanno dato forma? Se l’uomo crea delle forme sociali per dare un senso alla vita stessa e la società esiste proprio in quanto da lui creata, perché non fa in modo che quell’ambiente diventi una società accogliente, che non lo costringa ad auto-violentarsi per conformarsi alla cultura che, essendo appunto creata, è altro da sé, quindi estranea? Questa mediazione non sarebbe proficua affinché venga mantenuto un equilibrio, senza auto-costringersi a rinunciare obbligatoriamente a se stesso?
Del resto, come dicevamo, è la stessa antropologia della specificità a proporre nelle sue teorie una società accogliente, che non faccia venir meno l’unicità dell’uomo stesso. Ma perché l’essere umano che crea i modelli ai quali poi aderisce, non li crea a immagine e somiglianza della vita, ma piuttosto della non-vita?
Durkheim ci dice che la natura dell’uomo è distruttiva. A questo punto, viene da chiedersi se, essendo tutto negativo, l’uomo comportandosi così voglia in realtà auto-preservarsi, per non auto-distruggersi definitivamente. E allora meglio conformarsi in toto a quei modelli, piuttosto che scomparire del tutto?
Tutte le volte che rifletto su queste cose imparate studiando sociologia sono abbastanza sconcertata, e provo sempre ribrezzo nel pensare che veniamo “riempiti” di socialità, a scapito della vera vita, perdendo di vista la nostra e l’altrui unicità. Quindi mi chiedo: avere una maggiore consapevolezza in merito ai meccanismi che stanno alla base della società non ci potrebbe aiutare ad essere delle persone migliori?






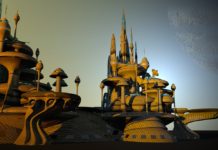



Facebook Comments