Chi fa da sé fa per tre. Parrebbe questa la lezione impartita da due recenti casi di cronaca sul problema troll, violenza online e legislazione carente – o che forse c’è, ma senza ancora la dovuta applicazione.
Ignorare il troll, il disturbatore online, è sempre la prima regola dinanzi a molestie virtuali. Resta principio saldissimo della Top 10 #SocialCare Rules già in altri casi richiamata come «bussola d’orientamento», exit-strategy, scialuppa di salvataggio in caso di crisis management, al centro anche dei miei recenti interventi a #SMX Milan 2015 e Italian Social Banking Forum 2015. Il Don’t Feed The Troll non è che l’altra faccia del «porgere l’altra guancia», che mai dev’esser cieco, del «metter il cuore» e tutto se stesso nell’aiutare e soddisfare il cliente-amico. Non si possono sprecare energie in chi non ne necessita, poiché cerca solo la rissa: in chi, anzi, quelle energie vuol distruggerle. Devo investirle su chi ha bisogno di me.

Certo però, se il troll insiste e trasforma gli attacchi in vera violenza – online e non solo – occorre ribadire un sonoro #StopWebViolence: in primis invocando giustizia, chiedendo aiuto alla legge, all’autorità. Che succede, però, se questa non risponde? Se latita o è carente, e io sono solo di fronte a chi, armato, vuol farmi del male?…
A risponderci il caso dalle traversie affrontate da un’illustre vittima di troll: tanti soldi, e tanti anni di vita, buttati dalla finestra per difendersi: senza ancora sapere come finire. «Finding Fuboy: one man spent four years and $35,000 to unmask his internet troll», titolava The Verge 3 settimane fa. «Alla ricerca di Funboy». Ossia, come perdere 4 anni e 35.0000 dollari per smascherare il proprio troll. Senza aver – almeno per ora – portato a casa niente o quasi.
I fatti: Illinois, 2011. L’avvocato Bill Hadley, candidato nel consiglio locale della contea di Stephenson, già seccato per alcuni contrasti interni, il 28 dicembre va su tutte le furie, leggendo il commento a un articolo sul Freeport Journal Standard: «Bill Hadley è un Sandusky che deve ancora essere scoperto. Guardate che vista ha da casa sua sulle scuole elementari». Firmato «Fuboy», con fotodella «vista» allegata, chiaramente scattata dalla casa.
Peccato che Jerry Sandusky sia un noto pedofilo, un criminale autore delle peggiori molestie su bambini che avvicinava facilmente, essendo allenatore di football. Hadley decide di andar fino in fondo e scoprire chi si cela dietro il nickname. Presenta denuncia formale. All’inizio neanche gli danno retta! Lui però insiste: dopo settimane, la Corte Suprema dell’Illinois obbliga il provider a esibire i dati dell’abbonato. Il colpevole? Frank Cook: procuratore della contea, che aveva lavorato con Hadley durante il primo mandato. Nasce un conflitto d’interessi. Tra carte bollate e spostamenti di sedi, si arriva a questi giorni: rinvio al 2016.
Vero che Hadley la sua vittoria l’ha già avuta: conoscere il nome di chi lo aveva infamato e poteva rappresentare un pericolo per sé e la sua famiglia. «Sì, lo conoscevo», ha dovuto ammettere poi lo smascherato troll, «nel senso però che al massimo lo salutavo se lo incontravo per strada»: cercando così di minimizzare. Di fatto, ha pure dovuto rassegnare le dimissioni. Restano però le decine di migliaia di dollari andate per arrivare al risultato: la fatica, l’attesa, il mal di fegato.
Come dimostrare poi i danni materiali e morali subiti dalla vittima a seguito della vicenda?
È come nello stupro. Ti violentano: dentro e fuori. Le tue ferite sono evidenti. E quelle che si vedono meno – ma non meno riconoscibili – fanno ancora più male. Sai persino chi è stato. Eppure a te l’onere della prova. E vai a denunciare. Vai a subire altro male, condannandoti a cause infinite, dove ogni udienza, a ogni testimonianza, rivivrai il massacro. Chiaro che poi la violenza – spesso proprio la più frequente e allucinante, quella casalinga – cedi alla tentazione di buttarla come polvere sotto il tappeto.
Cerchi di dimenticare: sapendo bene che non ce la farai mai, che magari anche riaccadrà presto. Ma tutto è meglio. Non così per Hadley: che ancora oggi, però, vive nell’attesa.
Non paragoniamo certo le due situazioni. È però il principio dell’ incertezza legislativa, della carenza giurisprudenziale che preoccupa.
Microsoft è stata, ad esempio, molto criticata per aver rivelato in un caso analogo il nome di un blogger dissidente in Thailandia, su richiesta della Corte. E frequentissimi sono ormai i procedimenti legali per smascherare utenti di Reddit o Twitter: non ultimo il caso dell’attore James Woods, lanciatosi in battaglia a suon di carte bollate per scoprire l’identità di un anonimo “cinguettante” troll che lo accusava di essere dipendente dalla cocaina. Comune denominatore? L’incertezza, appunto, dell’esito, della conclusione: nei tempi e nei modi. Non sai mai come va a finire. Spesso ci si accorda in via transgiudiziale. Oppure te la giochi: e lì la sola certezza è la parcella, inevitabilmente salatissima, che dovrai sborsare quantomeno ai tuoi legali.
«Il problema sta nella natura incerta della legge sulla diffamazione», spiega Olivera Medenica, avvocato specializzato sul tema, interpellato da The Verge. «Hadley dovrà dimostrare i danni patiti attribuibili all’accaduto – un compito per niente facile», conclude Medenica.
Il reato, insomma, è evidente – almeno in moltissimi casi. «Le leggi son», si direbbe con Dante, «ma chi pon mano ad esse?». E quand’anche si volessero applicare, si finisce sempre con lo scoprire all’ultimo che «quella che proprio ci servirebbe, che proprio farebbe al caso nostro»… «Ops, ci manca!». La pena, insomma, è quella che come al solito latita.
Ben hanno fatto – verrebbe da dire allora – in Brasile, dove all’inno di «Virtual racism, real consequences», hanno preso a spuntar come funghi cartelloni pubblicitari per le strade del Paese, riproducenti tweet e post offensivi e violenti lasciati dai troll in rete. Non strade qualsiasi, però: quelle là, proprio là accanto o di fronte alle case degli stessi troll autori delle calunnie. «Tu mi svergogni online? E io ti svergogno offline»: ti umilio davanti a tua moglie, ai tuoi figli se ne hai. Se non la pianti, se la legge non c’è, ti faccio almeno maledire il giorno che mi hai incontrato.


Iniziatori del progetto i Criola, gruppo di attivisti contro il razzismo, a difesa delle donne di colore. Come riportato da Visual News, l’iniziativa è partita dopo che Maria Julia Coutinho, giornalista TV di colore molto amata in Brasile, è rimasta vittima di un vero fuoco di fila di commenti razzisti online: e proprio il 3 luglio, in occasione della Giornata Nazionale contro la Discriminazione Razziale. Approfittando della geolocalizzazione di moltissimi tweet e post in rete, e dunque della già disponibile rintracciabilità fisica dei relativi autori (troppo difficile per le autorità usare gli strumenti di geotag?…), gli attivisti hanno preso a piazzare i cartelloni proprio nei luoghi da cui gli atti di violenza erano partiti. Della serie, come nei film horror, «Caro troll, so cosa hai fatto».
«Specchi del razzismo» il nome della campagna. A spiegarla al meglio questo video:
«Abbiamo omesso nomi e facce degli autori», spiega il gruppo, che si è servito di pixel. «Vogliamo solo che la gente prenda consapevolezza di questa piaga e s’inizi a discuterne seriamente, affinché si capiscano le conseguenze reali di questi commenti su Internet, prima di postarli». «Razzismo virtuale, conseguenze reali», si chiama infatti il progetto, che sul sito elenca anche le regole da seguire per passare parola e smascherare i diffamatori online ogni volta che se ne incontra uno.
L’idea ha fatto già molto parlare: da ITV News, che il 30 Novembre era partito con «Campaign sees people’s racist comments put on billboards near their homes», a The Next Web, che subito dopo titolava «Racist trolls are being shamed with billboards showing their abusive messages near their homes» – per rilanciare la notizia pure poche ore fa. «Dopo tutto, il peggior nemico del razzismo è il silenzio», recita il manifesto del gruppo.
C’è forse da dargli torto?




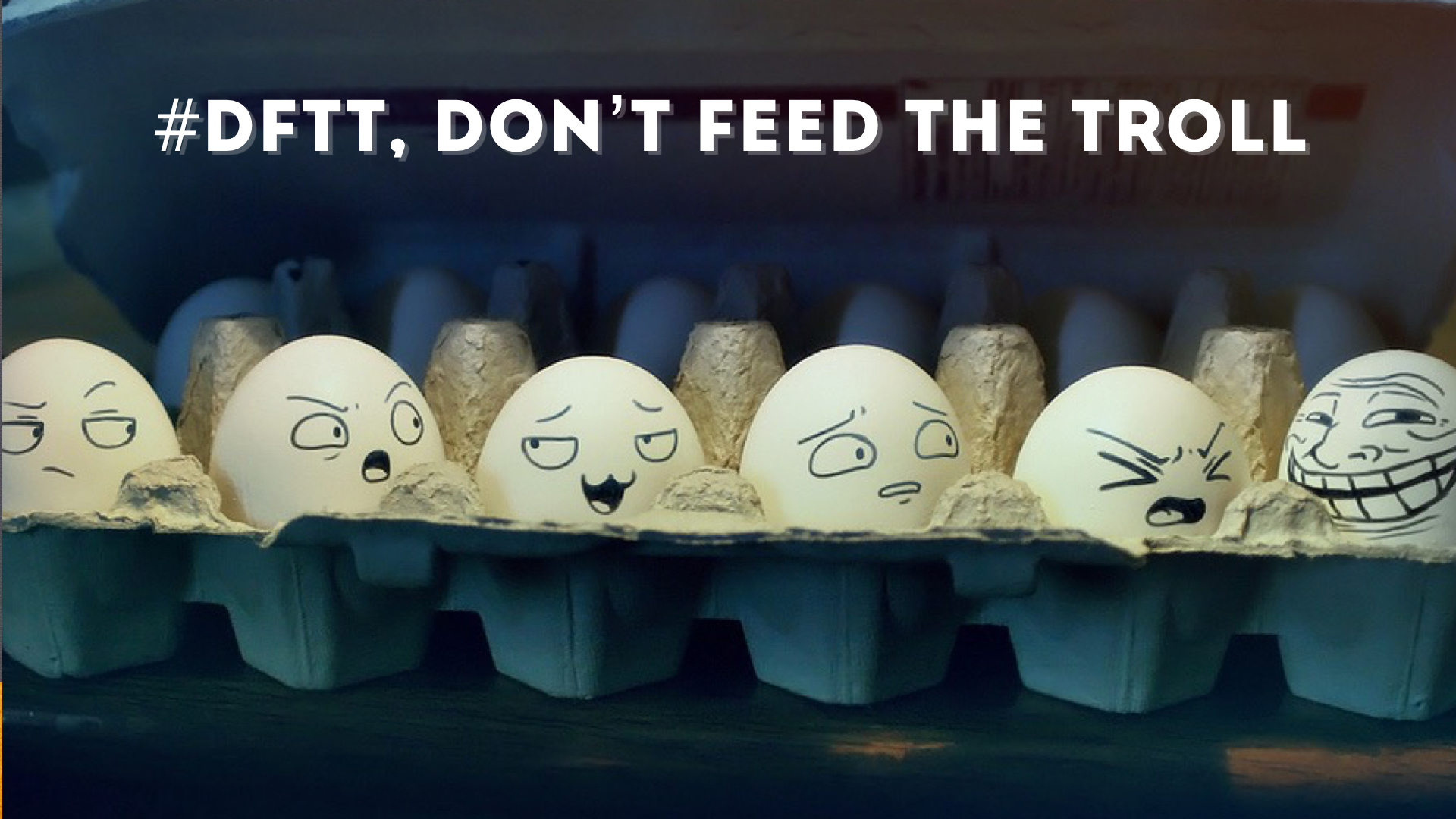





Facebook Comments