Qualche giorno fa ho letto un interessante saggio sui temi dell’insegnamento e dell’apprendimento, The examined life. L’autore (docente in un college inglese) discute limiti e errori presenti sia nella scuola che nell’università.
Tra le varie osservazioni, cita e commenta un passaggio di Martha Nussbaum:
‘Teaching to the test’, which increasingly dominates public school classrooms, produces an atmosphere of student passivity and teacher routinisation. The creativity and individuality that mark out the best humanistic teaching and learning has a hard time finding room to unfold.
L’autore cita anche un passaggio di Karl Popper che val la pena ricordare:
If I thought of a future, I dreamt of one day founding a school in which young people could learn without boredom, and would be stimulated to pose problems and discuss them; a school in which no unwanted answers to unasked questions would have to be listened to; in which one did not study for the sake of passing examinations.
Osserva l’autore:
There are some who question whether any such thing as ‘teaching someone to think’ is possible, but it happens naturally enough under the right conditions. How do you learn anything at all? Aristotle said we learn by doing. It isn’t a matter of passively absorbing information: learning happens when we try to do something. We learn to swim by trying to swim; we learn to play the flute by trying to play it. What Aristotle didn’t mention is the need for supervision: we need someone watching us to tell us when we are getting it wrong, and how to improve. Learning is supervised trying.
L’articolo è ricco di riflessioni e considerazioni che dovrebbero essere approfondite da insegnanti, politici, studenti e genitori, troppo spesso impegnati a difendere i propri figli invece di preoccuparsi delle loro formazione ed educazione.
Ne ho discusso con alcuni colleghi in università e uno di essi, l’amico Claudio Citrini, mi ha mandato una mail che vale la pena leggere perché smonta tanti luoghi comuni e fanfaluche che si leggono sull’università (italiana) e sul valore e sulla natura dell’apprendimento.
Scrive Claudio:
Da tempo in coda ai miei programmi d’esame compare questa (ahimé sempre più vana) frase che descrive i “risultati di apprendimento previsti”:
“Il docente si attende una comprensione non limitata alla enunciazione di definizioni e di risultati e alla risoluzione di esercizi standard, ma critica e in grado di distinguere le diverse situazioni e di compiere scelte consapevoli, giustificando i procedimenti seguiti. Si attende inoltre una adeguata correttezza nei calcoli e una esposizione ben argomentata della teoria.”
Purtroppo gli studenti sono sempre meno disposti a studiare consapevolmente: non glielo insegnano più a scuola, salvo ottime eccezioni, ed è molto più difficile insegnarlo a questa età. Non so se sono (ancora? o mai stato?) adeguato a ott enere questo risultato, ma è il vantaggio incalcolabile che i nostri studenti ricavano dal sistema Politecnico — e in generale Italia — quando vanno all’estero, in posti dove appunto si passano esami standard con test standard. Non disperdiamolo! Il compianto Giuseppe Biardi mi ha insegnato una frase di Boltzmann che trovo verissima: “Non c’è nulla di più pratico di una buona teoria”. La fuga di cervelli non è certo colpa, se non in minima parte, della corruzione, ma è comunque possibile solo perché sono buoni cervelli.
Purtroppo anche da noi si va diffondendo la mentalità che un corso si giudica dalla percentuale di studenti che supera l’esame. Ma è facilissimo raggiungere il 100%, e molto meno faticoso che selezionare. Un vecchio aforisma politicamente scorrettissimo (quindi, di quelli che piacciono a me) dice: “La percentuale di programma che gli studenti ricorderanno dopo aver passato l’esame è pari alla percentuale dei riprovati”.
Le osservazioni di Claudio potranno sembrare dure, ma rimandano all’essenza del processo di apprendimento e ricordano i meriti di un modello formativo troppo spesso dileggiato e criticato, ignorando da un lato la realtà dei fatti e, dall’altro, i risultati ottenuti dai giovani che in questo sistema si sono formati.
Ma noi parliamo di questi temi? Discutiamo forse di come potenziare e migliorare l’istituzione universitaria?
Siamo così occupati a indignarci per le parentopoli vere o presunte che perdiamo la capacità di analizzare seriamente i problemi, come ricorda in un articolo di qualche giorno fa di Alessandro Campi (pubblicato su Il Messaggero e ripreso da istitutodipolitica.it):
Dovrebbe far riflettere, per cominciare, il fatto che ogni volta che si parla della dilagante corruzione universitaria, si citano sempre gli stessi casi eclatanti e si fanno sempre gli stessi nomi: il clan Frati a Roma, il clan dei Tatarano e dei Massari in quel di Bari. Vicende ben note alle cronache, e assai biasimevoli, ma che tuttavia non rappresentano la normalità. Semmai la patologia di un mondo nel quale si accede con difficoltà e spesso non secondo merito, ma sulla base di appartenenze e filiere che però non sono primariamente parentali, ma semmai ideologico-politiche (ancora oggi, alla faccia delle fine delle ideologie) o più banalmente corporativo-disciplinari o meramente localistico-territoriali (il candidato del luogo è ormai sempre favorito rispetto al forestiero). Ma nel quale la stragrande maggioranza dei docenti — vogliamo dirlo in maniera chiara? — occupa il proprio posto in virtù delle proprie personali competenze scientifiche.Per tornare alla fuga dei cervelli, causata secondo Cantone dalla corruzione dilagante e dal malaffare nei concorsi, essa in realtà dipende dalla miseria crescente dei fondi destinati in Italia alla ricerca e all’università. I laureati più brillanti e i dottori di ricerca se ne vanno all’estero semplicemente perché in Italia non si fanno più concorsi. Ovvero se ne fanno pochissimi, e quei pochi fortunati che entrano dei ranghi, dopo trafile estenuanti, spesso si debbono accontentare di quell’obbrobrio rappresentato dalla figura del “ricercatore a tempo determinato”: 3 anni più 3 di contratto col rischio dunque di trasformarsi in precari a vita. Non parliamo poi dei livelli retributivi, irriguardosi per persone che spesso accedono al ruolo avendo superato abbondantemente la trentina e avendo delle famiglie da mantenere.Il problema è che l’Italia — intendendo i governi degli ultimi vent’anni di ogni colore politico — ha smesso di credere nel valore strategico della ricerca superiore e della formazione universitaria. Si è proceduto, anno dopo anno, ad un politica sconsiderata di tagli negli stanziamenti pubblici e i risultati sono quelli che oggi si vedono: una drastica riduzione degli studenti iscritti (solo in parte correlata con la decrescita demografica del Paese), una percentuale di laureati sul totale della popolazione tre le più basse d’Europa, una classe docente assai anziana e che non si riesce a rinnovare, un’età media d’ingresso nella professione accademica intorno ai 37 anni e, appunto, un numero crescente di ricercatori giovani che se ne va dall’Italia. Qualcosa significa se la Corea del Sud (dove certo non mancheranno casi di nepotismo accademico e favoritismi nei concorsi) destina alla ricerca il 4,05% e l’Italia solo l’1,27% (la media dei Paesi Ocse è del 2,83%). Questa non è corruzione o malcostume, ma colpevole mancanza di visione politica.Viene anche da aggiungere che se i nostri giovani studiosi riescono così facilmente ad inserirsi nelle strutture accademiche internazionali è perché qualcuno li ha formati e preparati a dovere, non perché siano singolarmente dei fenomeni. E quel qualcuno è (in senso collettivo) quell’Università che nella rappresentazione mediatica di questi giorni si vorrebbe ridurre ad un generalizzato e riprovevole “tengo famiglia”. Nella fuga dei cervelli, indotta dalla penuria di risorse statali e dall’inconsistenza di un mercato privato della ricerca, l’aspetto più sgradevole è proprio questo: noi prepariamo i giovani, investendo ingenti risorse nei singoli percorsi formativi, per poi chiudergli le porte in faccia al momento del loro inserimento professionale e regalarli così belli e pronti alla Gran Bretagna, alla Francia o magari alla Cina e alla Finlandia. Non è anche questa una forma di danno erariale che però nessuno ha ancora contestato allo Stato italiano?La denuncia a scadenze fisse delle parentopoli universitarie, nell’Italia che odia le élite professionali d’ogni tipo e che sembra preferire la delegittimazione pubblica di intere categorie sociali alle persecuzione delle colpe individuali, fa effetto e si vende mediaticamente bene. Va nell’onda dell’antipolitica e della messa alla berlina delle caste d’ogni tipo. Ma oltre a gettare sull’Università più fango di quanto non meriti, poco serve per capire i mali e i problemi che davvero l’affliggono. Peccato, perché una discussione pubblica e non scandalistica sul futuro dell’Università italiana sarebbe invece quanto mai necessaria e utile.
(Nota: è interessante leggere anche l’articolo del collega Ciro Ciliberto, presidente dell’Unione Matematica Italiana.)
Credo non ci sia molto da aggiungere. Noi tutti (docenti, politici, giornalisti, genitori e studenti) saremo capaci di dare una risposta seria e all’altezza delle sfide che sono di fronte a noi?




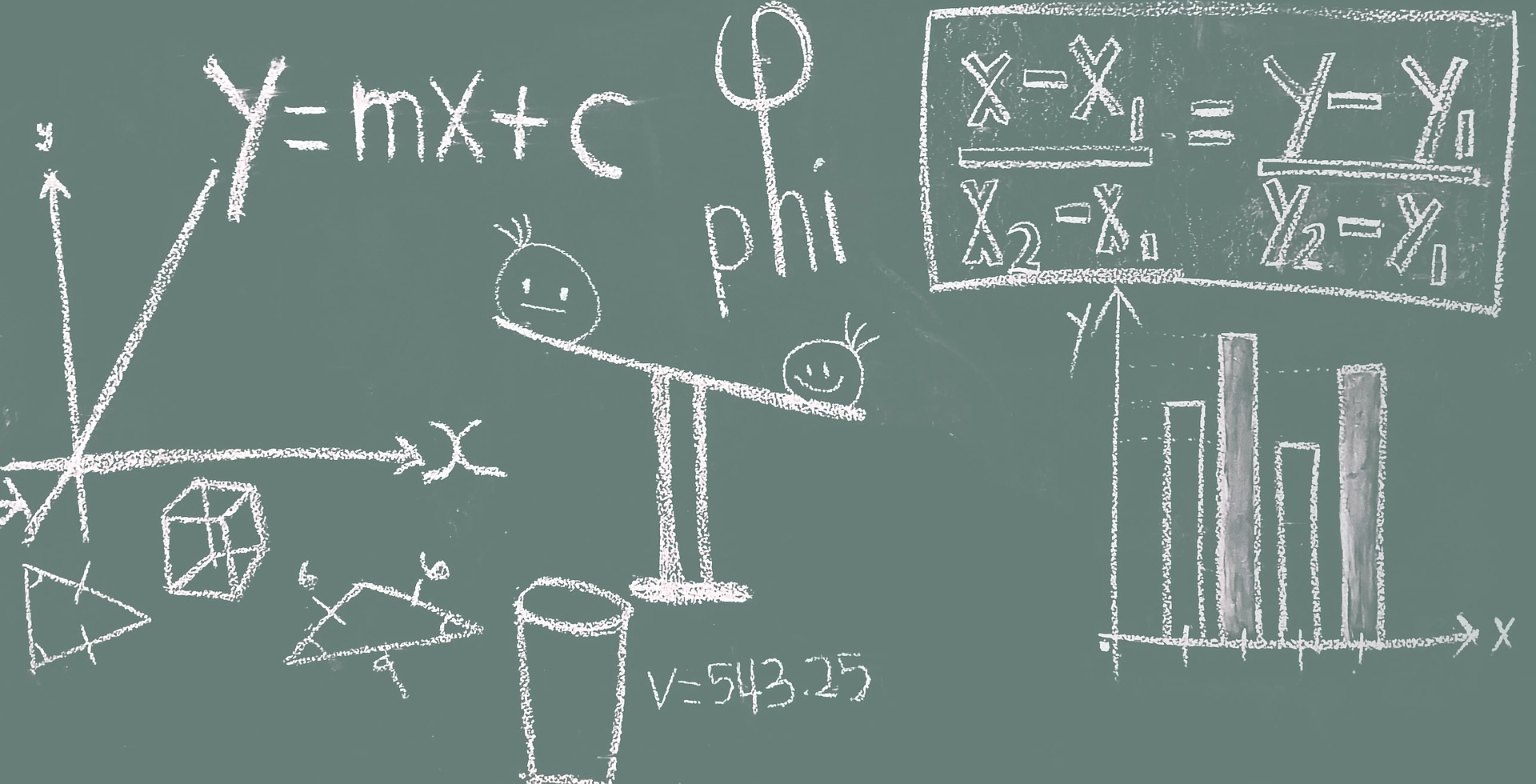





Facebook Comments