Era lo scorso giugno quando il Ministro Calenda, parlando della lunga, complessa ed ancora irrisolta situazione dell’Alcoa, diceva testualmente sulla radio di Confindustria:
“Tra le crisi che vorrei risolvere c’è l’Alcoa. Sarà molto difficile, perchè l’Alcoa è in una zona molto difficile, quella del Sulcis. Una sfida difficilissima e la cosa che mi ha molto colpito è che questi lavoratori vogliono fare gli operai; cioè per loro fare gli operai è un riscatto della modernità dall’agricoltura. E io questa cosa qua la trovo anche un po’ emozionante”.
Un riscatto della modernità dall’agricoltura. Tanto basta per comprendere molto del punto di vista di Carlo Calenda, da sempre uomo d’industria, su tutto ciò che industria non è. E tanto basta, senza entrare nel merito della crisi dell’Alcoa, per rendersi conto del punto di vista del suo Ministero e delle politiche pubbliche che da esso dipendono quando si parla del ruolo dell’industria per il nostro Paese. Una visione tardo ottocentesca che vede nell’industria un’evoluzione, nella fabbrica un progresso, nell’operaio un momento di riscatto sociale riscatto rispetto al ruolo di contadino. Una visione di un’industria ottocentesca per un Paese che – indipendentemente dagli sforzi e dagli sfaceli fatti per trasformarcelo – non è mai stato “soltanto” industriale (pur essendo l’Italia il secondo paese industriale in Europa dopo la Germania, va ricordato), e mai lo sarà. Ma il problema della visione di Calenda non riguarda solo la Sardegna dell’Alcoa, ma tutto il Paese; quel Paese in cui l’80% del Prodotto Interno Lordo non è prodotto dall’industria. Quel Paese, però, in cui l’80% dell’attenzione – quando si parla di politiche pubbliche di supporto – è rivolto all’industria. Evidentemente qualcosa non funziona.
A non funzionare è la convinzione che la ripresa del nostro Paese non passi per la sua natura, ma per una sorta di processo di industrializzazione che – rivenduto in salsa 4.0 – fa tanto storytelling ma di sostanza ne ha ben poca. Perché poco importa che lo storytelling ultimamente stia mostrando più di qualche limite, quando ci consente di agganciarci ad un trend mondiale di cui tutti parlano. E di ciò di cui tutto il mondo parla – in fondo – non si può che parlar bene. Poco importa capirne il senso. Poco importa capirne la contestualizzazione rispetto ad un paese come il nostro. Certo, a Carlo Calenda va dato l’indiscusso merito di aver portato all’attenzione generale un tema di grande rilevanza, e di averlo fatto con una forza che nessun suo predecessore aveva mai avuto. Ed è indubbio che la nostra industria per rimanere competitiva debba declinare le logiche proprie delle tecnologie digitali nell’ambito di quelle industriali, pensando in termini di additive manufacturing, di advanced automation e di tutto ciò che il mondo ha ormai definito “Industria 4.0”.
Che tutto ciò basti, però, è un altro paio di maniche. Un paio di maniche che nessuno vuole indossare, perché la retorica dell’innovazione che spaccia Industry 4.0 come il trend dal quale possa emergere in Italia un nuovo modello economico che “sfidi” quello delle economie dove sono nati i grandi protagonisti della digital transformation è una retorica che fa comodo. È una retorica che coincide con quella per la quale si parla di “ecosistemi di startup” facendo finta di dimenticare che l’Italia non è un paese per startup, e che spingere migliaia di giovani ad investire in questa direzione altro non è che un sistema per far guadagnare coloro i quali attorno a quell’ecosistema vivono e vegetano: incubatori, acceleratori e chi più ne ha più ne metta. Si chiama “modello Klondike”: quel modello che spiega che gli unici a guadagnare sicuramente in una corsa all’oro sono quelli che vendono i picconi ai minatori. Poco importa che i minatori ci si giochino la testa, nella corsa all’oro.
Industry 4.0, nel discorso pubblico italiano, sfrutta lo stesso (infido) modello di comunicazione adottato dai retori delle startup a tutti i costi: parliamo di qualcosa di cui non si può che parlar bene (perchè è evidente che il trend di Industry 4.0 vada cavalcato) e di cui non si può che vantare la dimensione innovativa mentre, quando tutti ne parlano, propiniamo al Paese soluzioni che prendono in considerazione una parte (le industrie, appunto) per il tutto (ossia tutto il resto del PIL).
E quindi così come chi parla di Startup fa intravedere all’orizzonte un Paese salvato da un’improbabile nuova Google (rendendo peraltro il lavoro molto più complicato per chi di startup si occupa veramente, e sono tanti anche in Italia) chi parla di Industry 4.0 ne parla cercando di spiegare che quella nuova Google sarà l’industria verso la quale il nostro modello economico deve dirigersi. Ed ecco quindi che i retori dello startuppismo a tutti i costi si sposano con i teorici dell’Industry 4.0 in salsa teutonica (eh si: l’abbiamo copiato dai tedeschi) e tutto sembra filare liscio come l’olio.
Se non fosse che è abbastanza improbabile che sarà una nuova google all’amatriciana presente nel “registro delle startup innovative” (pure per le startup siamo riusciti a creare un albo!) a salvare l’Italia. Così come è improbabile che, magicamente, Industry 4.0 trasformi un tessuto economico che non è mai stato esclusivamente industriale cambiandone la natura. E disperdendone il valore. Proprio così: disperdendone il valore. Perché pensare che la salvezza del nostro paese passi dalla capacità di copiare un modello piuttosto che da quella di comprendere come sfruttare il nostro valore adattandolo alle caratteristiche del mercato è un errore. Un errore che si basa sull’equivoco per il quale “processo di industrializzazione” equivale ad “industrializzazione di processo“. E se è vero che il nostro non è un tessuto economico fatto da aziende che possono vivere di processi industriali è altrettanto vero che tutte le nostre aziende che vogliono essere competitive devono essere capaci di ripensare i propri processi nell’ottica della trasformazione digitale e – quindi – sviluppare un percorso di industrializzazione dei propri processi. Il che non vuol dire trasformarli in processi industriali né più ne meno di quanto acquistare una stampante 3D non trasformi un artigiano in un maker. Il nostro è un paese di artigiani che possono trarre grandi benefici dalle tecnologie proprie dell’Industry 4.0, ma che non deve pensare di sostituire gli artigiani con i maker, che hanno un altro ruolo, un altro valore ed un altro senso.
Tornando al Ministro Calenda con la sua Alcoa che avrebbe avuto il merito di elevare allo status di operai gli agricoltori del Sulcis: siamo sicuri che quegli stessi operai oggi non avrebbero tratto maggiori vantaggi da un programma finalizzato a valorizzare l’agricoltura su quel territorio? Un programma magari basato sullo sviluppo sperimentale di modelli di smart farming integrati con processi di valorizzazione del turismo in una zona sottoutilizzata in tal senso ma caratterizzata da scenari e contesti unici? Siamo sicuri che la via dell’industria sia sempre la migliore? Siamo sicuri che dell’Industry 4.0 l’Italia debba essere una protagonista attiva nell’ambito dei processi industriali e non piuttosto come attore capace di sfruttare quell’industrializzazione di processo che potrebbe valorizzare il nostro patrimonio in termini di paesaggio, cultura, cibo? Siamo certi che – ancora una volta – la strada debba essere quella che sino a oggi si è dimostrata fallimentare, ossia il tentativo di copiare modelli esteri sperando che si adattino come un vestito di pronto-moda alle caratteristiche uniche del nostro Paese, piuttosto che decidere di diventare sarti e cucire addosso alle peculiarità dell’Italia una ricetta che sia capace di partire dai nostri elementi di valore? Il che vorrebbe dire comprendere cosa vuol dire Industry 4.0 per l’Italia, e rendersi conto che ogni azienda può sviluppare ed essere attore di innovazione: che lavori nell’agrifood come nel turismo, nel commercio come nell’artigianato. Il che vorrebbe dire non aspettarsi che i problemi del nostro Paese li risolva una nuova Google nata tra Treviso e San Donà di Piave, ma comprendere come tali problemi debbano essere affrontati aiutando il nostro tessuto imprenditoriale a sfruttare il contesto economico, commerciale e sociale sviluppato dalla digital transfomation, di cui Industry 4.0 è un aspetto che ne declina un approccio. Un approccio del quale tutte le nostre aziende, piccole o grandi che siano, devono capire le dinamiche per sopravvivere e crescere. E non basta dire che l’azione governativa vede in Industry 4.0 una serie di azioni di supporto all’industria e nel piano crescita digitale riassume la dimensione strategica per gli altri settori. Non basta per due motivi: in primo luogo il piano crescita digitale è quanto di più aleatorio ed indefinito potesse essere concepito da mente umana ed in secondo luogo le agevolazioni economiche sono su Industry 4.0 e – benché possano essere effettivamente sfruttate da aziende di qualsiasi dimensione – sono pensate per supportare la dimensione industriale. Ma soprattutto perché Industry 4.0 non è una questione di tecnologie per l’industria, ma una questione di cultura.




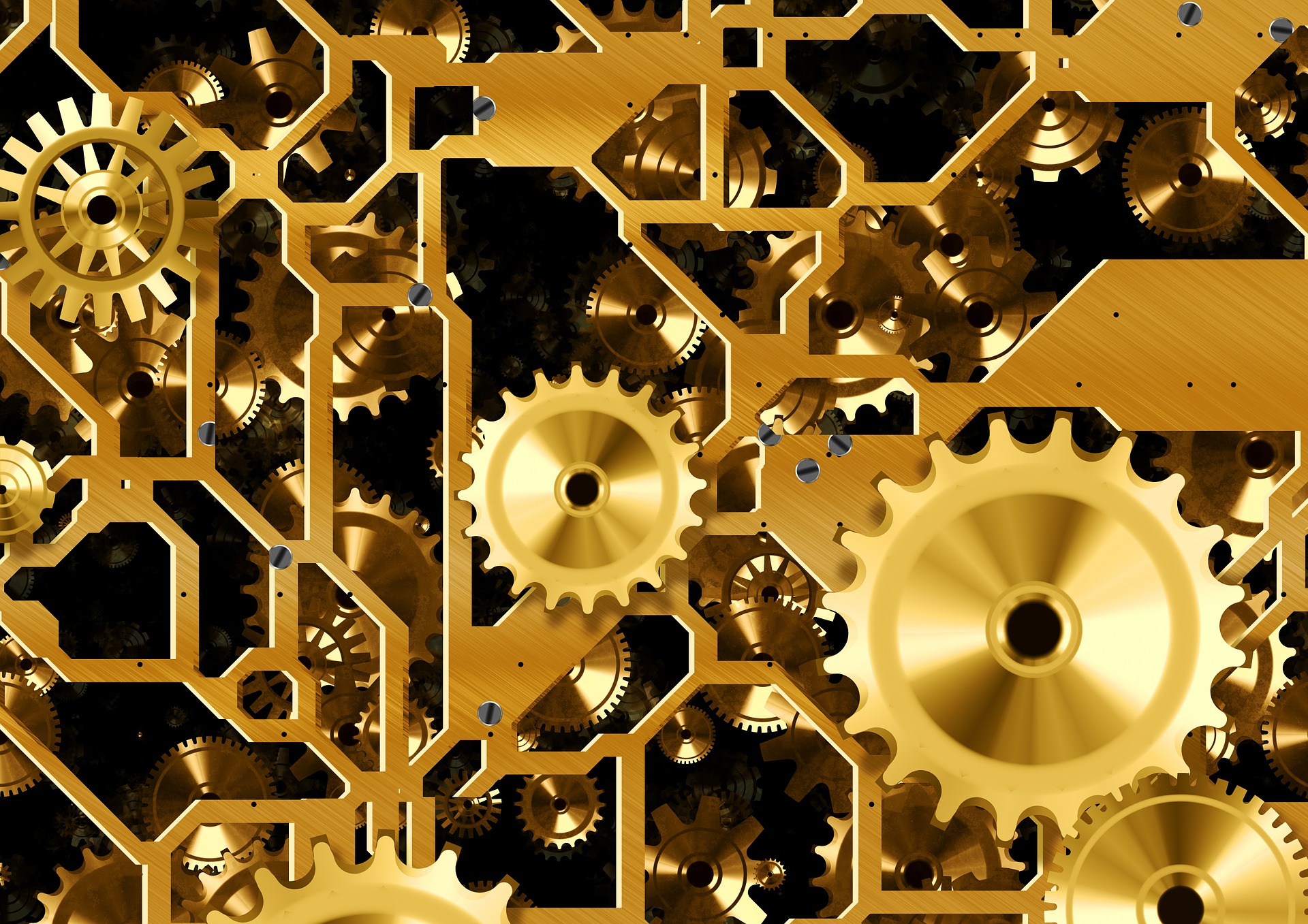
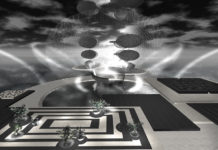




Facebook Comments