Non certo all’improvviso e inattesa (in verità era un segreto molto male custodito) è giunta la notizia che Google ha ricevuto una sanzione antitrust dalla Commissione europea per una presunta violazione delle norme antitrust del Vecchio continente, avendo alterato, si dice, i propri algoritmi di ricerca per sfavorire i concorrenti rispetto al proprio servizio di comparazione dei prezzi. La sanzione sarà di 2,4 miliardi di euro.
C’è chi s’impressiona alla cifra, chi solleva le spalle pensando che le riserve di cassa del gigante di Mountain View sono un multiplo piuttosto consistente di quella cifra. In realtà, come spesso accade, non è la sanzione in sé a causare problemi all’impresa oggetto del provvedimento, ma la condanna a porre termine alla violazione. Google entro 90 giorni dovrà alterare in modo sufficiente i propri algoritmi di ricerca per dare parità agli avversari. Il che a quanto so è la prima volta che accade a un motore di ricerca.
Algoritmi “squilibrati”
L’accusa è chiara. Il motore di ricerca non ha usato un algoritmo neutro, ma ha usato un algoritmo “alterato” (“biased”) che ha come effetto (voluto) quello di presentare i servizi di Google con posizionamento più favorevole. Ora, siccome gli algoritmi dei motori di ricerca (come è giusto che siano, da un punto di vista commerciale) sono segreti, si evince che la Commissione ha fatto un lavoro a risalire. In effetti il fact sheet pubblicato dalla Commissione fa riferimento da un lato al posizionamento preferenziale (in un’area apposita dei risultati) dei propri servizi; dall’altro evidenzia che quelli dei concorrenti appaiono solo nell’area riservata ai contenuti generici; in più si parla di “pesi” negativi intenzionali applicati ai concorrenti, il che sembra più difficile da argomentare.
Prendendo per buona la ricostruzione dell’autorità, è chiaro che il comportamento non è vietato in sé. Infatti, un qualsiasi sito di un qualsiasi servizio può decidere di promuovere un altro servizio dello stesso operatore, o mettere in maggior risalto i propri prodotti senza con questo ledere i diritti di altri concorrenti. Non esiste un codice di comportamento dei motori di ricerca. Ma Google ‒ dice la Commissione ‒ non è un qualsiasi sito. È motore di ricerca di gran lunga dominante sul proprio mercato. Per questa dominanza è in grado di alterare il gioco della concorrenza perché è in grado di estendere la propria dominanza dal mercato dei motori di ricerca in settori adiacenti (cross-market leverage). Dunque letteralmente fa leva sul potere di mercato nel proprio settore per accrescere, fino a diventare dominante, il proprio potere su un altro mercato. Non è una teoria nuova, la stessa Commissione l’ha applicata nel famoso caso Microsoft, dove la casa di Redmond venne giudicata abusare del proprio mercato nel settore dei sistemi operativi per PC al fine di creare, rafforzare e mantenere una posizione dominante nei servizi di rete nel settore workgroup. Interessante il fatto che ora Microsoft siede dalla parte degli accusatori.
Da un grande potere deriva una grande responsabilità
L’immortale detto dell’Uomo Ragno rappresenta in modo plastico l’essenza dell’abuso di posizione dominante. Ciò che è consentito ai normali non è consentito ai troppo forti. Sia chiaro, cercare di costruirsi una posizione dominante non è di per sé illegale; viene punito solo l’abuso di tale posizione. In questo caso l’abuso viene rinvenuto in una decisione tecnica di cui sappiamo molto poco. In effetti, per quanto ne sappiamo, Google potrebbe favorire un partito politico, un’impresa, un attore, a scapito di altri, e noi non potremmo nemmeno supporre. Possiamo vedere che Google presenta risultati diversi da Bing o da DuckDuckGo o da Yandex. Ma chi ha ragione? Il motore che ha più successo o quello che insegue? Chi ci dice che non siano gli altri ad alterare i risulti? Ma poi, alterare rispetto a cosa?
Non esiste un algoritmo vero e uno falso, uno giusto e uno sbagliato. Un algoritmo di ricerca è una serie di funzioni matematiche e semantiche incredibilmente complesse, che vengono elaborate in decenni di raffinamenti e contrappesi, necessari tra l’altro per evitare che gli stessi vengano sfruttati da chi ha intenzioni poco caritatevoli (una volta si parlava di “Google Bombing”, l’alterazione intenzionale dei risultati di ricerca tramite la pubblicazione di contenuti con certi criteri). Toccando una parte di essi, si rischia di alterare il bene stesso che l’impresa produce: ricerche affidabili che restituiscono i risultati più pertinenti alla stringa introdotta per il maggior numero di utenti.
Dall’altra pare esiste un rischio non indifferente di conflitto di interessi. Nel caso di oggi è evidentemente un conflitto d’interessi gigantesco: Google ha tutto l’interesse a favorire i propri prodotti, fino a quando l’alterazione dei risultati non ponga a rischio la sua credibilità e il suo potere nel mercato dei motori di ricerca, cosa molto difficile da conseguire. Può dunque adottare comportamenti anticoncorrenziali senza temere un effetto negativo sul proprio mercato (questo è appunto un cardine del concetto di posizione dominante). Se lo fa, non esiste uno standard al quale fare riferimento, una misura indipendente e affidabile dell’alterazione. Perché tutto ciò che fa riguarda una formula matematica straordinariamente complessa, il cui know how appartiene veramente a pochissimi: in pratica solo ai propri concorrenti, che però hanno tutto l’interesse (contrario, speculare) a dimostrare alterazioni anche quando alterazioni non ci sono.
È un problema che non ha una soluzione, perché applica categorie commerciali tradizionali in un campo che è totalmente alieno.
Un problema di piattaforma
Google sarebbe solo l’epitome di un concetto di abuso del potere concesso da una piattaforma. In realtà tutti i più grandi servizi informatici pubblici, quelli di successo, da Google ad Amazon, da Uber ad Apple, a questo tendono: a cercare di imporre la propria piattaforma, in cui sono signori e padroni, in un mondo in cui ‒ per usare un’altra citazione cinematografica ‒ ne resterà solo uno (nel proprio macro-settore). Le piattaforme sono caratterizzate da notevoli effetti di rete, un fenomeno per cui un servizio ha tanto più valore quanto più è usato; quanto più ha valore esso è appetibile per i fornitori, tanto più avrà condizioni iperconcorrenziali, tanto più sarà usato dagli utenti, eccetera, eccetera, in un meccanismo in cui chi per primo raggiunge sufficiente massa critica toglie lo spazio di esistenza agli altri, fino a che un nuovo paradigma non si impone.
Questo ruolo negli anni ’70-’80 è stato giocato da IBM con il mainframe. Negli anni ’90-’2000 da Microsoft con Windows e Office. Microsoft è stata in larga parte scalzata dai servizi in cloud, in cui Google da un lato, Amazon e Facebook da altri lati (infrastruttura cloud e commercio online l’uno, social media e dintorni l’altro) tendono ad essere più che il dominatore, l’operatore totalitario.
Il limite naturale ai monopoli è la contendibilità della posizione. Se un operatore è dominante, ma un nuovo operatore può rapidamente rimpiazzarlo offrendo servizi concorrenziali più appetibili, la dominanza è solo apparente. La contendibilità è possibile con basse barriere all’ingresso. Nella tecnologia degli anni ’90 e ’2000 le barriere sono state tenute più basse dalla sussistenza di un certo grado di interoperabilità data da sforzi rilevanti dei concorrenti nella ricerca tecnica, da azioni antitrust che hanno avuto parziale successo, dalla richiesta di standardizzazione venuta da operatori pubblici e privati. Ovviamente l’interoperabilità e la standardizzazione assumono significati molto diversi in un mondo dove i sistemi sono “altrove”, al di fuori del controllo dell’utente finale, il quale usa il servizio ricevendone solo il risultato finale attraverso gli strumenti di controllo messi a disposizione da chi gestisce il servizio in cloud.
Evoluzioni
Non è finita qui. Google ora potrà impugnare il provvedimento in sede giudiziale, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (due gradi di giudizio). Inoltre, si potrebbe aprire un contenzioso sul (mancato) rispetto dell’ordine di porre fine alle condotte anticoncorrenziali.
Inoltre, non è l’unico caso aperto in Europa. Esistono altre due indagini, iniziate successivamente, una sul sistema operativo Android (a cui per un breve tratto ho partecipato anch’io, per aspetti che sarebbe lungo discutere qui), un’altra sul servizio AdSense, ovvero la pubblicità online attraverso la quale molti siti traggono sostentamento.
È dura capire se la Commissione stia andando nella direzione giusta oppure stia semplicemente dando udienza a sore losers, perdenti amareggiati. Quello che è certo è che si tratta ancora una volta di un terreno inesplorato. Io ho avuto la fortuna di essere nel mezzo della battaglia con il caso Microsoft e posso oggi dire, a distanza di molti anni, che la Commissione ha creato quasi dal nulla buon diritto antitrust, mettendo le basi per restaurare la concorrenza in un settore essenziale e centrale. Speriamo che sia altrettanto lungimirante e profetica oggi. Solo il tempo ci dirà chi ha ragione






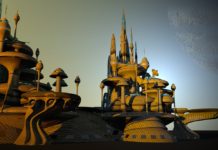



Facebook Comments