L’openness ha una faccia oscura, che si fa vedere solo attraverso un messaggero fumoso e impercettibile. È il “Cloud Computing”, tanto di moda nei circoli di quelli che parlano di innovazione, non sempre a sproposito. Il cloud, però, non è altro che un software dei cui servizi ci avvaliamo tramite interfacce e protocolli via rete. Software che sta da qualche parte, sovente su un computer di qualcun altro, a cui quindi non abbiamo accesso, se non tramite “servizi” che vengono esposti via rete. Internet, nei diagrammi, viene spesso rappresentata come una nuvola, da cui “Cloud”. Questi servizi vengono fruiti o direttamente, tramite una pagina web accessibile in un browser, o “dietro le scene”, tramite altri protocolli e interfacce in cui sono i computer e i relativi programmi a parlarsi tra loro. Protocolli e interfacce che vanno sotto il nome di “API”. Ecco spiegato il titolo, almeno la prima parte.
Un problema di disponibilità
Negli articoli precedenti abbiamo discusso come le questioni dell’openness nascono principalmente dalla “chiusura” data da diritti di privativa (diritto d’autore, brevetti, diritto _sui generis_ del database). In certi casi, come per il software distribuito come codice oggetto, la mancanza di accesso al codice sorgente impedisce un’adeguata modificabiltà (dunque adattabilità) del software. Mancanza tutelata dal diritto attraverso la tutela del segreto (il codice sorgente è considerato segreto, cercare di rivelarlo tramite decompilazione è generalmente vietato, salve eccezioni: una di queste è appunto la ricerca dell’interoperabilità, di cui diremo oltre). Nel caso di software accessibile solo via rete – come nel cloud computer, ma anche in tutti i casi in cui occorre interfacciarsi con altro software detenuto da altri e reso accessibile via rete – la ragione di possibile mancanza di apertura deriva principalmente dal fatto che il software è da qualche altra parte a cui non si ha fisicamente accesso, e comunque che non si controlla.
Non che ciò sia necessariamente una cosa negativa, semplicemente è uno scenario diverso da quello concettualmente più semplice, di un sistema IT di cui si “controlla” tutto, dall’hardware fino agli strati superiori. Per controllo intendo quanto meno avere la potestà della decisione di installare o disinstallare una componente (hardware o software, libera o proprietaria che sia). Se il software è installato altrove, la decisione non è mia, posso solo usare quello che mi viene messo a disposizione via rete.
Un problema di API
API sta per “Application Programming Interface”, ed è un termine che indica l’insieme di modalità di interazione tra due componenti software. Si distinguono dalle GUI (o semplcemente UI) acronimo di “Graphic User Interface”, ovvero l’interfaccia uomo-computer, perché – come ovvio – l’elemento umano non interviene, tutto avviene in modalità automatica; nel cloud computing, e in genere nelle applicazioni “distribuite” su varie risorse, l’interazione avviene via rete (RPC calls, web services, eccetera). Nel prosieguo parleremo indifferentemente di “specifiche”, “protocolli”, “interfacce”, “API”, i quali, benché concettualmente differenti, ai fini della nostra analisi possono essere usati in modo intercambiabile.
Se dunque io voglio creare un’applicazione che “parli” con una applicazione che espone delle API, ho almeno due ordini di problemi: di accesso (logico e fisico) e di ordine giuridico (copyright e brevetti, in primo luogo).
Il segreto: specifiche non documentate, che ballano il Samba
Le interfacce possono essere perfettamente accessibili, ad esempio nel caso in cui il software sia tutto locale e le API siano “esposte” (ovvero non serva una chiave o un altro componente per interagire), ma essere sconosciuta la lingua che parlano.
Un caso che ha fatto scuola, e che conosco sufficientemente bene per aver partecipato direttamente ai vari processi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è il caso Microsoft. Parlarne compiutamente sarebbe troppo lungo, ma il caso verteva sulla possibilità che un operatore indipendente reimplementasse i protocolli e le interfacce di rete dei sistemi Microsoft Windows, facendo “finta” di essere dall’altra parte un sistema Windows. Le API dei sistemi di rete di Windows non sono pubbliche, a differenza delle API che consentono ai programmi di interfacciarsi con il sistema operativo locale: esse sono (erano) tenute segrete, almeno da una certa data in poi (per coincidenza, più o meno da quando Microsoft era diventata “dominante” nei sistemi “workgroup”).
Un sistema operativo diverso, per esempio Linux, non aveva dunque la possibilità di “inserirsi” in una rete Windows. Non poteva fare il server in una rete di client Windows, non poteva fare il server in un gruppo di server Windows, non poteva fare il client in una rete di server e client Windows, se non tramite protocolli diversi e meno adatti. Era nella stessa situazione di un cliente in un caffè francese che non sapeva parlare francese, aveva i soldi, ma non sapeva come ordinare qualcosa (né esattamente cosa ordinare). La metafora viene da una descrizione.
Samba è una reimplementazione dei servizi di rete di Windows, nata dal protocolo SMB (da cui il nome “Samba”) ad opera di Andrew “Tridge” Tridgell, una delle persone più geniali che abbia mai conosciuto. Per aggirare il segreto che a un certo punto era sceso sui protocolli nelle nuove versioni della parte di servizi di workgroup server (condivisione di file, servizi di autenticazione e stampa), egli si mise ad “annusare” il traffico di rete tra due macchine Windows, per scoprire – riusiamo l’analogia – come si chiama quel pezzo di pane lungo e strano, o quella bevanda in quella tazza, come si fa una domanda invece di un’affermazione, cercando di capire i pezzi della “lingua” che compone il protocollo, il ruolo di essi, la giusta sequenza, come combinarli per fare una domanda e per dare una risposta e così via. Fino a creare un componente che, visto dalla parte del server “Windows”, sembrasse un altro Windows. E poi sostituire la macchina Windows con Samba, per vedere i messaggi di errore generati intenzionalmente e imparare ancora di più.
Alla fine, il risultato delle azioni a cui ho partecipato è stato di ritenere che il segreto imposto da Microsoft sui propri protocolli fosse contrario alle normative antitrust, perché consentiva alla stessa di controllare in modo indebito uno standard “di fatto”, che era essenziale per competere nel mercato. Il segreto infatti non necessariamente doveva essere su tutto per frustrare “l’interoperabilità, ma poteva anche limitarsi a pochi dettagli tenuti nascosti, un granello di sabbia gettato negli ingranaggi dei propri concorrenti, che interrompesse la piena interoperabilità. La condanna a fornire ai concorrenti complete e tempestive informazioni sui protocolli è stata confermata dal tribunale europeo.
I brevetti
Risolta la parte sui brevetti, il Team Samba (e io per loro) si è ritrovato nella situazione di avere pieno accesso alle specifiche dei protocolli di Microsoft, perfettamente documentati in modo tempestivo e completo, come richiesto dalla decisione della Commissione (il ritardo nella fornitura di tale documentazione è costato a Microsoft quasi tre miliardi di multa).
Il problema è che la documentazione non è del tutto sufficiente per poter implementare i protocolli senza problemi legali. Infatti, i protocolli di Microsoft sono tutelati da brevetto. Questo significa che chiunque voglia implementare gli stessi protocolli in un’applicazione che si vuole interoperabile (ad esempio Samba), necessariamente rientra nell’ambito di protezione dei brevetti. Nel caso di Microsoft i brevetti facevano comunque parte del pacchetto-condanna, ma sono poi stati concessi in larga parte sotto l’Open Specification Promise, un impegno a non utillizzarli “aggressivamente”, il che ha effetti simili a una licenza generale. Alcuni protocolli, tuttavia, rimangono fuori, come ad esempio Active Sync, un protocollo che consente di sincronizzare informazioni tra device differenti. Altri casi potrebbero essere rilevanti.
Copyright
Per il diritto d’autore, la situazione è più sfumata. Infatti è idea comune che le interfacce non siano protette da copyright. Questo perché il copyright copre, come abbiamo già detto varie volte, solo la forma di espressione originale, e non l’idea. Corollario è che tutte le volte in cui la forma di espressione coincide con l’idea, perché esiste solo un modo per “dire” una determinata cosa, esprimere un determinato concetto, usare il copyright sull’espressione equivale a usarlo sull’idea.
In Europa questo concetto è stato espresso in modo chiaro e inequivocabile nel caso SAS Institute v. World Programming Language (Caso [C-406/10]). In tale caso un concorrente ha reimplementato in modo perfetto le interfacce e i protocolli (e i formati di file, ma è un’altra questione) di SAS, una società che produce un famosissimo e costoso programma di statistica. L’obiettivo dichiarato era quello di far sì che i programmi statistici sviluppati per SAS dagli utilizzatori (dunque non materiale di SAS) potessero essere utilizzati in modo corretto nel programma concorrente. Sostanzialmente la stessa cosa che vuole fare Samba, raggiungere quel livello in interoperabilità che si chiama “drop-in replaceability”: la capacità di prendere un pezzo del sistema, rimpiazzarlo con un pezzo diverso, senza che nessuno se ne accorga. La stessa cosa che facciamo quando una lampadina si rompe e la rimpiazziamo con un’altra: il risultato è luce, perché la seconda ha lo stesso passo, usa la stessa tensione e frequenza dell’altra.
La sentenza della Corte è stata appunto nel senso di consentire questa ricostruzione, nonostante nell’implementare i protocolli il concorrente abbia dovuto riusare un “dizionario” di variabili e costrutti _identici_ a quelli di SAS, i quali, visti da soli, sarebbero stati da chiunque considerati proteggibili. Tuttavia, in quanto usati come interfacce, essi sono stati considerati non oggetto di copyright. La stessa cosa sembra dover poter essere la situazione giuridica delle interfacce negli USA, solo che in quel sistema si giunge a situazioni simili attraverso il _fair use right_, il quale (è una sottigliezza importante) è una causa di giustificazione, non una condizione di esenzione dal copyright. Questa differenza è importante ed è al momento in cui scrivo discussa nel caso sulla reimplementazione in Android delle interfacce e protocolli di Java (e delle relative librerie). Pur essendo la norma, ai fini pratici, sostanzialmente identica, il grado di certezza con cui ne parliamo è quindi diversa, in quanto la sua applicazione concreta è ancora, almeno in parte, “sub judice”).
Andiamo nelle nuvole
Abbiamo visto che ci sono vari diritti e situazioni protette da diritto coinvolte. Tutte però presuppongono che le interfacce “esistano” e siano rese disponibili. Niente impone a nessuno di crearle e renderle disponibili, in quanto nessuno (o quasi) può imporre al titolare di un servizio di creare un pezzo di software, ma al massimo la legge può limitare il livello di controllo tramite il diritto (incluso il segreto, anch’esso tutelato da un diritto, ovvero il divieto di decompilazione).
Il sistema usato da Samba per ricostruire i protocolli e interoperare con le interfacce presuppone che le interfacce possano essere utilizzate e il traffico tra di esse (“through the wires”, attraverso i cavi) possa essere intercettato e analizzato, tramite un’operazione particolare di “reverse engineering” (di tipo osservazionale, non di decompilazione del software). Il reverse engineering presuppone però di avere accesso all’oggetto dell’analisi. Se chi ospita il software in cloud non rende disponibili determinati servizi, non esiste niente che possa aggirare tale mancanza. Se non è possibile esportare i dati attraverso l’applicazione, non è possibile nemmeno attraverso il sistema operativo o il motore di database su cui magari il software si appoggia, come nel caso in cui il software sia installato su una macchina del cliente.
Ciò ha conseguenze in caso di cessazione del contratto con l’operatore dei servizi in cloud. Il rimedio a questa situazione sembra essere puramente contrattuale, o anche semplicemente giudiziario. Dunque occorre rendere obbligatorio e contrattualizzato, ad esempio, un sistema per garantirsi di non perdere dati e l’operatività anche senza la collaborazione dell’altra parte. Una combinazione di presidi tecnici e contrattuali che garantiscano (ragionevolmente) tutto ciò. Altrimenti in un ambiente cloud gestito da altri si è molto più vincolati al fornitore di un sistema in cui si controlla tutto.
Un cenno all’antitrust e conclusioni
Nel caso Microsoft, però, la società americana è stata condannata a fare qualcosa: produrre una documentazione accurata, completa e tempestiva (aggiornata) in cui pubblicava le informazioni di interoperabilità dei propri protocolli. È un rimedio esperibile solo nel caso in cui ci sia un operatore in posizione dominante sul mercato e questi ne abusi. Un caso raro, si dirà? Sarà, ma a me è capitato di occuparmene almeno in tre casi diversi, in tutti e tre i casi con l’apertura di una indagine formale – nel caso Microsoft – con una condanna, in un caso diverso – riguardante i servizi innovativi nella scuola – con impegni formali (un patteggiamento) delle imprese dominanti, nel terzo caso, appena diventato di dominio pubblico, nel caso del fornitore di servizi del processo civile telematico.
Questo dimostra che la tentazione di usare la posizione di chiusura data dal controllo delle interfacce è molto alta, il conflitto di interessi rischioso e il rimedio antitrust disponibile solo in determinati casi. Occorre dunque vigilare e tenerlo presente allorché si affidi ad altri una parte del nostro sistema informatico, avendo sempre presente una exit strategy nel caso incerto solo nel quando, non nel se, di abbandono dell’attuale fornitore. Il rischio di lock-in in questo caso è estremamente alto.





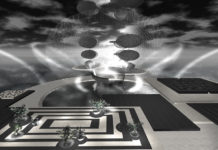




Facebook Comments