In questi giorni sono negli Stati Uniti per lavoro e non ho potuto fare a meno di sentire un po’ di commenti e interventi, soprattutto in campo Repubblicano, nel dibattito sulle nomination per le presidenziali di novembre. Sono rimasto colpito dalla banalizzazione estrema dei problemi. Sento affermazioni come “make America great again”, “non vinciamo più”, “io sono uno di successo perché ho fatto i soldi” e affermazioni ancora più banali. Confesso che sto rivalutando i nostri tanto bistrattati talk-show: qui riescono a fare pure peggio.
Stamattina sono uscito a fare due passi e mi sono ritrovato a pensare a queste e ad altre questioni di casa nostra.
Abbiamo problemi complessi che non riusciamo a risolvere. In tanti ambiti ci riduciamo a fare operazioni di immagine, senza essere capaci di analizzare le cause ultime di quel che viviamo. Banalizziamo le questioni, prendiamo posizioni spesso antiscientifiche, viviamo di complotti e chiacchiere da bar, dove le scie chimiche si combinano con il Bilderberg e le chiacchiere dei salotti dei “bene informati”. Siamo immersi in una continua spirale al ribasso, dove vale la notizia che fa spettacolo o l’affermazione pseudo-scientifica del momento.
Questo problema lo vivo innanzi tutto dove lavoro, nel mondo dell’università. Viviamo di stereotipi, come “i baroni corrotti e nulla facenti” e “l’università che fa schifo”. Dipendiamo da ranking che non hanno alcunché di scientifico, ma che fanno tendenza e ci condannano quotidianamente sui media e nell’immaginario delle persone. Io stesso a volte mi trovo ad usarli in modo difensivo, come una sorta di argine per dire “non facciamo così schifo”. E in questo modo mi rendo io stesso complice e vittima di un sistema distorto, esagerato, artificiale, che ha esasperato e banalizzato concetti e idee anche ragionevoli, trasformandoli in totem, in idoli, in stereotipi vuoti.
Viviamo di metriche che qualcuno ha inventato e che definirebbero ciò che è “buono”: quanti studenti stranieri si hanno o il basso tasso di ritiri o la velocità di attraversamento del percorso di studi. Qualcuno ha definito questi ed altri parametri come la chiave del successo e nessuno si permette di fare una semplice domanda: è così? È vero che un numero alto di studenti stranieri è di per se stesso un fatto positivo? Certamente, se studenti stranieri decidono di venire in una nostra università vuol dire che questa è attrattiva. Ma per chi? I bravi che la scelgono perché è il top, o quelli meno bravi che non sono stati presi altrove? E non è forse vero che il mondo migliore per avere tanti laureati, tutti in regola con le tempistiche definite per quel corso di studi, sia quello di abbassare la qualità e la severità del percorso didattico? Domande ovvie che però non fanno breccia: siamo vittime delle semplificazioni e soprattutto di ciò che fa tendenza, indipendentemente dalla qualità che quella tendenza intrinsecamente esprime.
Ma il problema è molto più generale e trasversale. Manca la dialettica del confronto, che spesso è sostituita dallo scontro mediatico, dalle frasi ad effetto che convincono i superficiali, dall’artifizio retorico che ti “fa avere ragione”, dalla battuta che elude il problema, ma ti dà modo di spuntarla sul piano della comunicazione. Viviamo lo storytelling e l’evocazione del sogno come strumenti di convincimento e motivazione, senza che siano collegati a concretezza e approfondimento serio del tema in discussione, privi di sostanza, credibilità e fattibilità. Viviamo di annunci e di rivendicazioni che gli annunci si sono trasformati in realtà anche quando così non è.
La verità è che non siamo capaci di approfondire i problemi perché sono troppo complessi o perché richiedono tempo per essere capiti e affrontati. Viviamo alfabeti e costanti di tempo incompatibili con la complessità e quindi reagiamo con la semplificazione o, peggio, manipolando i problemi e la realtà per trovare conforto o per conquistare facile consenso.
È una continua rincorsa all’apparire, al fare bella figura, al “passare l’esame”, al “vincere il sondaggio”, a chi la spara più divertente o originale. Non ragioniamo più, non abbiamo né il tempo né la capacità di pensare e riflettere. È l’imperante cultura di una sorta di enorme fast-food mediatico dove vince il consumo veloce e il soddisfacimento del bisogno immediato.
Come reagiamo a tutto ciò?
Una prima risposta alla complessità è quello di ridurla, mascherarla, ingannarla quasi. Rendiamo la complessità digeribile a chi non sarebbe mai in grado di sostenerla. Non ci preoccupiamo di far crescere lo spirito critico, ma di edulcorare ciò che è troppo difficile da capire e metabolizzare.
Molte università, per esempio, invece di migliorare la capacità didattica e i modelli formativi, li rendono più abbordabili. Agli scritti e orali di una volta sostituiamo i test a quiz. Alla discussione critica in aula sostituiamo la fruizione spesso passiva dei MOOCS. Allo studio e approfondimento sui testi preferiamo la sintesi delle slide. Al capire i concetti preferiamo l’acquisizione delle nozioni per “rispondere alla domanda”.
Nella politica e nella società troviamo scorciatoie o capri espiatori o soluzioni bandiera che non risolvono i problemi ma che “bucano lo schermo”. E non ce ne rendiamo conto. E sì che dovremmo averlo imparato dopo vent’anni di illusioni e di stagnazione! Eppure siamo ancora lì a discutere di palliativi invece di prendere per le corna le questioni: sono troppo difficili da spiegare, da capire, da gestire.
L’unica vera strategia vincente, ahimè, è molto complessa, difficile e di lungo se non lunghissimo periodo. Consiste nel puntare sull’educazione e sulla cultura per aumentare in modo diffuso la maturità delle persone, il loro senso critico, la capacità di gestire la complessità. Ma questa strategia non si vende bene, né sui media, né in cabina elettorale. Anzi, tutto ciò che è cultura e educazione sono spesso percepiti come uno spreco: “non ci fanno mangiare”. Abbiamo dovuto sentire affermazioni irresponsabili del tipo “non studiate, non laureatevi, non serve: meglio se aprite una pizzeria”. Invece di alzare il tono del dibattito per renderlo capace di gestire la complessità, abbassiamo la discussione dei problemi per dare l’illusione che siano fruibili da parte di chiunque e cerchiamo così di conquistarne il consenso e anche l’ammirazione.
Invece di sviluppare un’analisi critica, puntiamo sulla narrazione. Invece dell’approfondimento, puntiamo sulla facilità di fruizione. Invece dell’esercizio e dell’educazione alla gestione della complessità, puntiamo sulla sua “consumerizzazione”. Cresce così il paese? Facciamo così il bene delle future generazioni?
NO.
Siamo diventati schematici, superficiali, estremi: o bianco o nero, o di qui o di là, o a favore o contro. È un finto pragmatismo che nasconde in realtà solo paura, fretta, ignoranza.
Dobbiamo riconquistare la capacità di gestire la complessità. Dobbiamo far crescere la capacità critica delle persone. Dobbiamo puntare sulla crescita delle menti, non sul loro svilimento.
È questo quel che stiamo facendo?
Purtroppo, a me pare di no. E questo è un problema ancora più grande di un ranking universitario che non ci premia o di un decimo di PIL perso nell’ultimo trimestre.
Avremo il coraggio di prenderne atto?




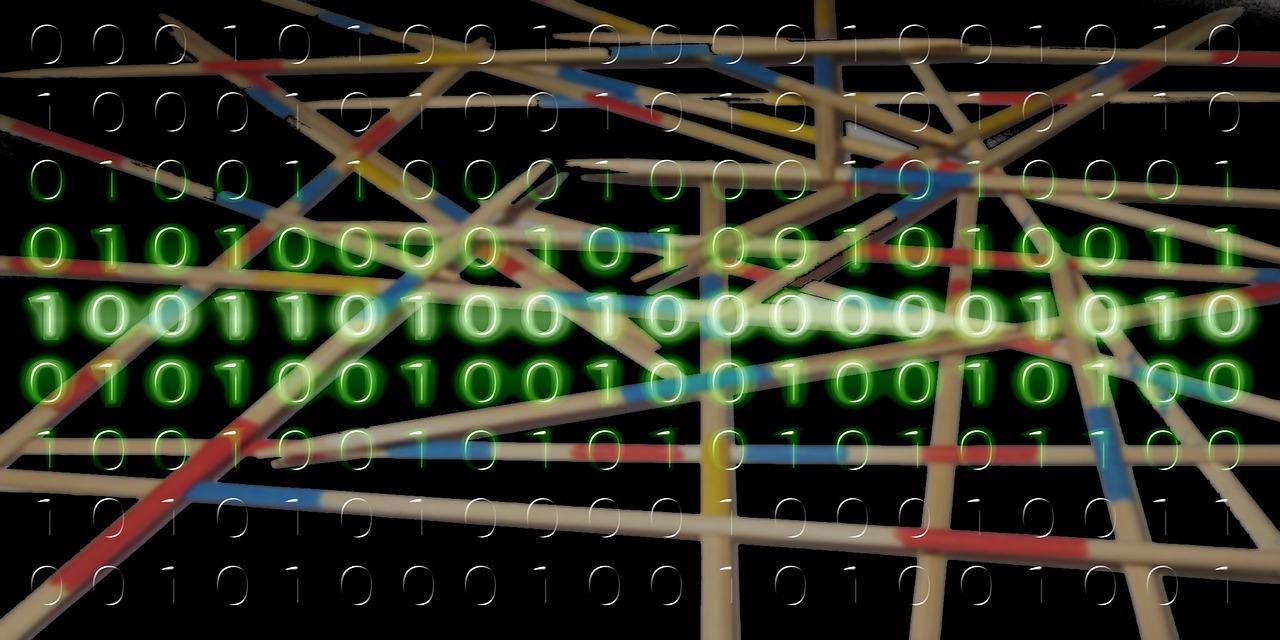





Facebook Comments