I riflettori dell’edizione autunnale della Milano Fashion Week si sono spenti da pochi giorni, ma i numeri che alimentano questo mercato, rilanciati durante questo seguitissimo evento, sono ancora ben impressi nei media di economia e finanza: l’industria italiana della moda (rivolta soprattutto all’export) quest’anno crescerà dell’1,4% arrivando a poco meno di 84 miliardi di euro (Camera Nazionale della Moda Italiana, elaborazione dati Istat, fonte: Il Sole 24 ORE ); parliamo quindi di una crescita circa doppia rispetto al PIL italiano.
La stessa vetrina delle Fashion Week milanesi vale da sola, considerando anche l’indotto, ben 42 milioni di euro (dato fornito da Cristina Tajani, assessore alle Attività Produttive e alla Moda, fonte “Il Sole 24 ORE). Parliamo quindi di un settore assolutamente strategico per l’economia italiana e per il brand del “Made in Italy”, ma quanto ci costa, nel senso più ampio del termine, questo mercato?
Lo stesso sito della Camera Nazionale della Moda Italiana, che cura gli eventi Fashion Week, offre una sezione dedicata alla sostenibilità che ci ricorda che “i tessuti e i pellami impiegati dai grandi brand del lusso mondiali sono in gran parte prodotti in Italia” e che nel 2012 la propria Commissione Sostenibilità ha pubblicato il “Manifesto della sostenibilità per la Moda Italiana”, un lodevole decalogo di principi, redatto con la collaborazione di importanti player italiani, che invita ad una produzione di qualità, locale, etica, trasparente e sostenibile. Ma oggi, al netto delle buone intenzioni, com’è la situazione? Le azioni concrete ci sono (ahimè non in Italia), ma sono drammaticamente insufficienti. Proprio poche settimane fa l’edizione europea del magazine Newsweek ha pubblicato un reportage dal titolo “Fast fashion is creating an environmental crisis” documentando gli aspetti più critici di questi emergenza:
- solo in America finiscono ogni anno tra i rifiuti ben 14 milioni di tonnellate di vestiti (circa 36 kg a persona)
- della parte di vestiti donati ad opere di beneficenza, solo il 20% riesce ad essere venduto, il resto finisce in discariche o inceneritori
- appena lo 0,1% degli indumenti raccolti da iniziative benefiche o programmi di recupero riesce ad essere riconvertito in fibre tessili (stima a cura della divisione per lo sviluppo sostenibile del marchio H&M)
- i tessuti ottenuti da fibre riciclate sono costosi, soprattutto in rapporto alla qualità ottenuta
- ad oggi non esiste un’agenda (vincolante) per una manifattura completamente sostenibile.

Zoe Romano
Per discutere di questo tema cruciale, e possibilmente individuare una soluzione, ci siamo rivolti a Zoe Romano, co-fondatrice del makerspace milanese WeMake e soprattutto co-fondatrice del brand Openwear, un progetto nato nel 2009, in seno al programma EDUfashion promosso e finanziato dall’Unione Europea, per sperimentare l’applicazione del modello collaborativo Open Source nel mondo della moda (abbigliamento, calzatura, accessori).
I risultati di questa sperimentazione, raccolti in un ebook dal titolo “OpenWear. Sustainability, Openness and P2P production in the world of fashion” liberamente consultabile online, si sono rivelati assolutamente attuali, al punto da essere ripresi dall’Open Source Fashion Manifesto pubblicato quest’anno dai designer Martijn van Strien e Vera de Pont per l’Het Nieuwe Instituut di Rotterdam, che ospita il Museo per l’Architettura, il Design e la Cultura Digitale ed è impegnato in attività didattiche e di ricerca.
Cosa ne pensi del reportage di Newsweek? Ti sembra puntuale o eccessivamente allarmista?
Il reportage non è eccessivamente allarmista anzi, tratta solo una parte del problema dell’impatto dell’industria della moda. Se ad esso aggiungiamo anche le considerazioni fatte sulla sostenibilità nel settore tessile, che è diverso da quello dell’abbigliamento, il quadro diventa anche più allarmante. Secondo i dati della Banca Mondiale il 20% dell’inquinamento globale delle acque industriali è infatti causato da tintoria e trattamento dei tessili.
Secondo te è possibile correggere l’attuale modello produttivo dell’industria della moda o bisogna cambiarlo o ridimensionarlo totalmente?
Come in altri settori molto diversi da questo, i cambiamenti più radicali non arrivano da dentro ma da fuori, da nuove imprese che decidono di entrare in un mercato con una proposta molto forte e che scardina la tradizione. L’editoria, la musica e la televisione sono cambiate perché forzate da player esterni, che erodevano quote di mercato con un approccio innovativo basato su una fruizione digitale, on-demand, customizzabile e spesso con una forte componente che democratizza la produzione e la diffusione di contenuti dal basso. Nella moda non sono ancora apparsi dei player che siano in grado di far cambiare le regole del gioco, se non per quello che riguarda l’e-commerce.
Sono passati 7 anni dall’avvio del tuo progetto Openwear: anche allora il tema della sostenibilità era così sentito o sono stati altri gli elementi che ti hanno ispirato?
Il tema della sostenibilità era già presente nel 2009, ma non era al centro del discorso che ha dato vita al progetto Openwear. L’obiettivo era piuttosto di indagare come potesse articolarsi un progetto di community con al centro una serie di commons: i cartamodelli digitali.
Quali risultati ha raggiunto il progetto e quali difficoltà hai incontrato?
Openwear continua ancor oggi a suscitare interesse per il tentativo che avevamo fatto di attivare concretamente una nuova prospettiva sulla moda, ribaltando alcuni assunti che tradizionalmente si danno per scontati. Avevamo fatto lavorare insieme un gruppo di designer, per poi rilasciare i codici della collezione collaborativa online come risorsa comune della community, a cui attingere per realizzare una produzione locale contraddistinta dal marchio Openwear, utilizzabile grazie a una licenza che ne permette l’uso se si rispettano alcuni principi condivisi.
Le difficoltà sono state di due ordini diversi: da un lato la mancanza di strumenti digitali che permettessero un abbassamento della barriere all’entrata per la realizzazione di cartamodelli digitali e parametrici, dall’altro una mancanza di skill digitali di chi viene da scuole di moda che dividono in modo rigido i creativi dai tecnici, formando quindi da una parte delle figure molto tecniche pronte a trasformare in realtà gli sketch forniti da “fashion designer”, dall’altra molti creativi che però non utilizzano strumenti digitali per il disegno. Penso che l’innovazione nella moda non sia solo un fattore estetico, ma che debba esserci una relazione più stretta su come viene gestita la produzione, sul come si fanno le cose e come i prodotti arrivano nelle mani di chi li acquista e per quale ragione.
Cosa ne pensi dell’Open Source Fashion Manifesto? Raccoglie fedelmente la ricerca svolta con Openwear e come giudichi il modello di economia circolare “fashion-as-a-service” che viene proposto?
Si, penso che raccolga molti degli spunti e visioni di cui ci eravamo occupati in Openwear. Il punto cruciale però è come mettere in atto queste visioni.
Rispetto al modello di economia circolare, posso dire che quando i prodotti fisici hanno una componente digitale molto forte diventano servizi, lo stesso accade quando il possesso del bene non è più necessario perché ci è sufficiente ragionare sull’accesso.
In quale maniera gli strumenti e le tecnologie Open Source possono contribuire al mondo della moda?
A differenza di quello che è successo nel contesto della stampa 3D, dove c’è stata un’esplosione di nuovi software e strumenti che facilitano la progettazione tridimensionale adatta a quella tecnologia e la condivisione dei file, nell’ambito della moda non sta accadendo lo stesso. Ci sono tuttavia alcuni esempi interessanti, come il progetto Open Source Valentina, che stanno lavorando in questa direzione.
Quali sono i progetti Open Source in ambito fashion che giudichi più interessanti o promettenti?
Il progetto della scarpa Open Source AnOtherShoe sviluppato da Eugenia Morpurgo e Sophia Guggenberger, che abbiamo recentemente ospitato per una residenza a Wemake, la borsa Taska di Ingi Freyr Gudjónsson, sviluppata al Fablab Barcelona, e le proposte di Post-Couture. L’aspetto interessante è che non si limitano a immaginarsi un nuovo prodotto, ma provano a mettere in atto, tra le altre cose, anche un nuovo sistema di manifattura distribuita e locale che si appoggia alle laser cut di FabLab e Makerspace.
A quali traguardi può ambire oggettivamente l’Open Fashion? Rimarrà a livello di sperimentazione e ricerca, conquisterà una nicchia di mercato oppure, magari con condizioni favorevoli, può ambire al mercato globale?
Ci son voluti circa 20 anni dalle sperimentazioni sul file sharing di musica, alla nascita dei primi esempi di servizi che hanno raggiunto un mercato globale, quindi direi che abbiamo ancora un paio di lustri abbondanti per sperimentare in alcune nicchie che riescono a cogliere i benefici di una moda aperta, customizzabile e on-demand, perché il mercato attuale non risponde ai loro bisogni e grazie all’entusiasmo degli early-adopters che ci supportano nel percorso.
Più che di Open Fashion, preferisco parlare di Moda Agile, un concetto che uso per esprimere una concezione di prodotto dinamico e maker-friendly, che non sia afflitto dall’obsolescenza programmata e prediliga una filiera corta sia per i materiali che per la produzione. Il punto di partenza è un blueprint digitale che, proprio in quanto digitale, può essere declinato su diverse modalità di produzione a seconda del feedback degli utenti, delle opportunità offerte dal network di servizi online e delle azioni che il produttore decide di intraprendere.
Il prodotto della Moda Agile diventa più simile a una piattaforma di azione in cui i produttori agiscono come facilitatori e costruttori di community intorno alla loro creatività. I loro strumenti sono digitali, il loro focus sulla qualità della progettazione e la loro ricchezza sono i network locali e globali con cui interconnettersi.





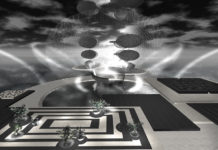




Facebook Comments