Comme te po’ capi’ chi te vo’ bene
Si tu le parle miezo americano?
Quanno se fa l’ammore sott’ ‘a luna
Comme te vene ‘ncapa ‘e di’ “I love you”?
R. Carosone, Tu vuò fà l’americano
Wide: in apparenza, un aggettivo irrilevante, ovverosia come ce ne sono tanti che transitano inosservati dall’inglese all’italiano, senza che il parlante, tutto sommato, se ne renda conto. In questo caso, però, il termine è sotto i nostri occhi tutti i santi giorni. A volerlo escludere, si causerebbe un danno socio-economico inimmaginabile. La sua traduzione immediata non comporta alcuna difficoltà: significa ampio. In parte, può essere considerato una specie prestito (un po’ di pazienza, prima di aggredire) essendo entrato nel nostro lessico in modo imponente, ma – bisogna ribadirlo – solo in parte. La locuzione “in parte” è funzionale e decisiva, giustificata dal fatto che wide mantiene, nella nostra lingua, una ‘collocazione’ ambigua: tanto inevitabile quanto occultata nell’uso stesso. In linguistica, quando si parla di collocazione, infatti, si fa riferimento a due o più parole che si presentano quasi sempre in co-occorrenza. Nel caso in specie, la combinazione dominante è world wide web, che si presume ciascuno di noi abbia pronunciata per intero, almeno una volta, negli ultimi vent’anni.
Il risvolto comico, tendente al grottesco, si materializza rapidamente: di là dalla morfologia, che per il momento sospendiamo o rinviamo a un successivo approfondimento, l’utente medio trasforma molto di frequente wide in wild (o, talora, anche wise). È probabile, di fatto, che si tratti non già di una trasformazione vera e propria, nonostante l’esito, bensì di confusione dovuta a una conoscenza della lingua inglese più millantata che reale. Insomma, vale quanto mai la catacresi (metafora morta) “Houston, abbiamo un problema”, che tuttavia, a propria volta, rappresenta l’ennesima storpiatura, giacché la forma originale era “Okay, Houston, we’ve had a problem here”, cioè “abbiamo avuto un problema”, comunicazione rivolta dagli astronauti dell’Apollo 13, Jack Swigert e Jim Lovell, al centro di controllo della missione NASA. Nella divulgazione popolare, s’è sostituito il present perfect con il simple present; “una cosa da poco” qualcuno potrebbe obiettare. Be’, non è proprio così.
È noto che la maggior parte dei termini dell’esperienza digitale proviene dalla lingua inglese ed è altrettanto noto che una conoscenza debole della lingua madre, che si manifesta anche in una pronuncia erronea, può allontanarci dalla piena comprensione dei fatti
Di certo, è molto più compromettente dire world wild web, anziché world wide web, giacché wild significa selvaggio. Il problema di base, cui abbiamo accennato in “Ti condurrei per mano”: messaggio senza melodia ed equivoco nella lingua digitale“, è insito nella questione fonetica, che i più trascurano, cioè nella differenza tra l’isocronia accentuale, propria della lingua inglese, e l’isocronia sillabica, propria invece di quella italiana. In pratica, il ritmo del nostro discorso è molto più lento rispetto a quello inglese e si articola in scansioni sillabiche, mentre il ‘discorso inglese’, diversamente, può anche essere foneticamente strutturato addirittura in gruppi di preposizioni e parole; il che talora c’induce a pensare che il parlante angloamericano ‘si mangi’ le parole. Qual è la pertinenza dei tratti prosodici con la comprensione d’una lingua digitale sostenibile? È noto che la maggior parte dei termini dell’esperienza digitale proviene dalla lingua inglese ed è altrettanto noto che una conoscenza debole della lingua madre, che si manifesta anche in una pronuncia erronea, può allontanarci dalla piena comprensione dei fatti.
La prima lettura ipertestuale dei documenti, vale a dire il sistema di rimandi da un link all’altro che ormai meccanicamente siamo soliti chiamare HTTP e che, esplicitato, diventa HyperText Transfer Protocol, risale al 1991 e il merito è da attribuire a Tim Berners-Lee, ricercatore del CERN di Ginevra di cui abbiamo parlato in precedenza, in Nel corteggiamento in chat il primo disastro digitale. La notizia giunse tuttavia al grande pubblico solo un paio d’anni più tardi, nel 1993. La storia, a tal proposito, è arcinota e gli amatori sono tanti. Forse, sono troppi gli esperti, ma, come si suol dire, bisogna farsene una ragione. Il web stesso, per il sostanziale attributo di wide, che assegniamo a esso per genesi, si espone al rischio di continuo fraintendimento e, talora, purtroppo, d’irredimibile insostenibilità.
Una domanda urticante potrebbe essere la seguente: conoscere la lingua inglese è un requisito necessario per ‘praticare’ il web da professionisti? Indubbiamente, per pubblicare qualche post e lanciare qualche campagna, spacciandosi per manager di qualcosa d’intangibile, è sufficiente – almeno questo, se non altro! – far corrispondere le parole ai significati. Se tuttavia ci si vuole aggiudicare il titolo di “professionista”, be’, allora non c’è scampo: la conoscenza dell’inglese è obbligatoria. Abbiamo affrontato questo tema più volte. In La bolla linguistica del para-inglese: qualcosa di (in-)sostenibile, in particolare, abbiamo pure messo in evidenza la prolificità con cui certi indefinibili personaggi si attribuiscono i titoli di social media manager, web marketing manager, content manager, personal branding manager et similia: prolificità che, il più delle volte, produce null’altro che clamorosa incongruenza. Se, recandovi dal pescivendolo, gli chiedeste dei merluzzi e in cambio riceveste delle triglie, quale sarebbe la vostra reazione?
Ebbene? Allo stesso modo in cui è doveroso proteggere la lingua italiana da quei signorotti inamidati dell’economia di facciata che non riescono proprio a non dire speech al posto di discorso e briefing al posto del legittimo e sacrosanto riunione, così abbiamo il dovere di anteporre le competenze alle chiacchiere e difendere l’opportunità digitale dall’invasione dei fanfaroni, millantatori e imbonitori.
Il world wide web nasce inglese, inglese resterà e non ammette altro codice di comunicazione. Un discorso simile può farsi, per esempio, per la filosofia, il cui percorso universitario è una delle più grosse anomalie didattiche della ‘scuola’ italiana: la filosofia nasce greca, eppure in nessun corso di studi italiano è previsto lo studio del greco. Lo studio della filosofia, senza una discreta conoscenza del greco, si rivelerà sempre parziale, monco, se non addirittura acefalo. Uno tra i primi atti prettamente filosofico-epistemologici fu il vedere, documentato nella Metafisica di Aristotele (980a). Ci si può sforzare a lungo di memorizzarne scrittura e contenuto, ma se non si capisce ciò che Aristotele intendesse con τοῦ εἰδέναι (tou eidènai) e quali siano i presupposti morfologico-semantici, non si fa altro che imitare il criceto che corre sulla ruota.
Dunque, non vogliamo che il proposito si muti in manierismo e non pretendiamo pure che il professionista digitale pronunci correttamente heart: /hɑːt/ (ne riportiamo la corretta pronuncia secondo i criteri dell’alfabeto fonetico internazionale), ma sulle pagine costruite ad arte dai ‘nostri’ maccheronici protagonisti si trovano, molto di frequente, delle uscite davvero ridicole e che farebbero ridere a crepapelle chiunque possedesse per lo meno i rudimenti della lingua inglese.
Per svolgere quest’ultimo tipo di ricerca abbiamo chiesto un parere a Cristina Maita, italo-statunitense, newyorkese per nascita e docente presso la Boston Extend. Il sostantivo “stamp”, per esempio, non indica affatto una stampa, ma è un francobollo. L’omografia può trarre in inganno, è vero, ma la pigrizia e l’ignoranza che ne deriva generano danni irreparabili. L’arcinoto “autostop” non appartiene neppure lontanamente agli angloamericani, i quali per esprimere lo stesso concetto dicono hitchhiking: quando si dice che spesso la convinzione è peggiore della malattia, in realtà, non si sbaglia affatto. Allo stesso modo, “eventually” non significa eventualmente, bensì alla fine; “library” non vuol dire libreria, ma biblioteca. I “preservatives” non sono dei preservativi, per quanto ai più possa sembrare sconcertante: sono dei conservanti. Dato che la lista sarebbe interminabile, ci fermiamo con un’ultima curiosità: il K-WAY, che per noi è il giubbino antipioggia, di fatto, è il marchio d’un’azienda fondata 1965 a Parigi e successivamente acquisita da BasicNet. Per metonimia sociolinguistica, abbiamo sostituito il produttore col prodotto. Accade molto di frequente: “compriamo le Nike”, “compriamo dei Levi’s” et cetera. Risulta un più problematica l’espressione “conosco Manzoni”, in considerazione del fatto che riesce difficile credere che qualcuno di noi sia andato a mangiare una pizza con l’autore dei I promessi sposi. Quest’ultimo, dunque, è un peccato veniale.
L’anglomania, in Italia, era già una moda intorno alla metà del XVIII secolo; non si deve pensare pertanto che essa sia recente né si deve continuare a dire, come si fa spesso e non se ne comprende il motivo, che gli anglismi si siano imposti nella parlata con l’avvento della società tecnologica.
Giuseppe Baretti, nel 1764, sulla rivista Frusta Letteraria, scriveva
“Che bella cosa, se mi venisse fatto di svegliare in qualche nostro scrittore la voglia di sapere bene anche la lingua inglese! Allora sì, che si potrebbono sperare de’ pasticci sempre più maravigliosi di vocaboli e di modi nostrani e stranieri ne’ moderni libri d’Italia! E quanto non crescerebbono questi libri di pregio, se oltre a que’ tanti francesismi di cui già riboccano, contenessero anche qualche dozzina d’anglicismi in ogni pagina.” (BARETTI, G., 1839, Aristarco Scannabue ai suoi partigiani, in Frusta Letteraria, tomo III, Tipografia Governativa della Volpe al Sassi, Bologna, p. 72)
È il caso di ricordare che Baretti, nel 1760, scrisse il primo dizionario bilingue, italiano-inglese, nella storia della nostra lessicografia. Sono trascorsi più di duecentosessantadue anni, ma potremmo ancora scrivere: “si potrebbono sperare de’ pasticci sempre più maravigliosi di vocaboli e di modi nostrani e stranieri ne’ moderni libri d’Italia”. Forse, occorrerebbe sostituire “libri” con ‘account’. Forse! Ma cambierebbe ben poco.




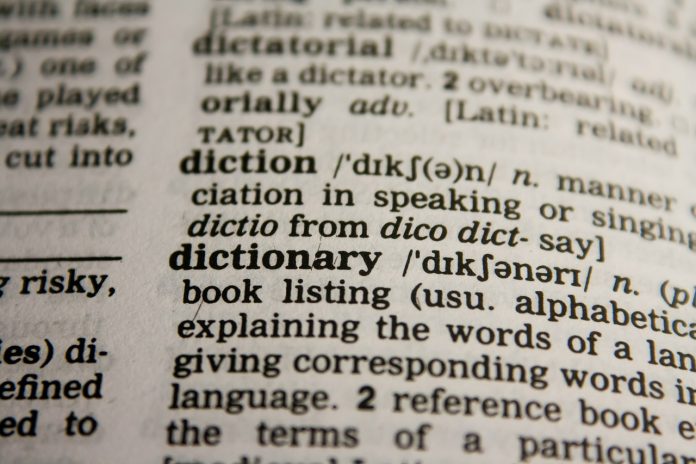





Facebook Comments