Si dice che il 13 sia un numero fortunato, ma in realtà se lo chiedete a un americano, il 13 è un numero sfortunato. Anche essere in 13 a tavola porta sfortuna.
Stupidaggini, ovviamente, ma gli appassionati di numerologia e gioco del lotto oggi hanno un altro numero 13 da tenere presente. E già che ci siamo, anche un 11. Sono gli articoli più controversi di una riforma del diritto d’autore, o copyright, altrettanto controversa. Nata con le migliori intenzioni ‒ adattare il diritto d’autore alle sfide delle tecnologie della comunicazione ‒ minaccia di diventare una delle peggiori creazioni legislative del nostro continente. L’articolo 13 di questa riforma è una delle peggiori parti.
L’articolo 13, nella formulazione che si sta discutendo in questi giorni si occupa in particolare delle piattaforme di condivisione di contenuti, sovvertendo uno dei principi fondamentali dell’attività degli intermediari nei servizi della società dell’informazione, quello di nessun dovere di monitorare i contenuti trasmessi. Oltre il danno, però, la beffa, con l’introduzione di alcune eccezioni che eccezioni non sono.
No duty to monitor o censura preventiva?
Quando in sede europea si ragionava (con una certa preveggenza) su come allocare in maniera efficiente le responsabilità per chi non produceva i contenuti, ma veicolava quelli di terzi, si è correttamente deciso che imporre doveri di monitoraggio dei contenuti da parte degli intermediari non coinvolti nella produzione del contenuto era estremamente inefficiente e avrebbe creato costi aggiuntivi tali di limitare lo sviluppo di tali servizi, aggravandone costi e incertezze. Imponendo obblighi di monitoraggio e correlative responsabilità si sarebbe creata una situazione di incertezza e possibili contenziosi. Il tutto con un prevedibile effetto limitativo dello sviluppo di tali servizi (“chilling effect”).
Il corretto bilanciamento, al di qua e al di là dell’Oceano è stato dunque rinvenuto in un principio di non responsabilità se non a seguito di una conoscenza precisa e circostanziata della illegittimità del contenuto veicolato. In realtà, anche così si sono create numerose fonti di incertezza e l’esatto confine non è mai stato correttamente individuato. Ad esempio, come sapere se un contenuto violi il diritto d’autore di un altro soggetto, se in molti casi per appurarne i diritti è necessaria una lunga causa? Ma anche nei casi più chiari di uso non autorizzato, come valutare se non fosse ad esempio un “uso libero” (es. diritto di citazione)? E stiamo parlando solo di copyright, ma la sua violazione è solo uno dei casi di illiceità, civile, penale, amministrativa (privacy, diffamazione, diffusione di segreti, apologia di reato, commercio di sostanze proibite, eccetera). Negli Stati Uniti, ma anche da noi, l’uso sconsiderato delle diffide pre-contenzioso (in USA la procedura di “notice and take down” è codificata in maniera precisa), nonché i costi e i rischi connessi con la gestione di tali attività, hanno comunque portato le più grandi piattaforme a prevenire il rischio in via volontaria introducendo filtri che individuano contenuti “illeciti”, soprattutto in violazione del copyright di major cinematografiche e discografiche, con effetti paradossali di censura preventiva e soppressione di utilizzi leciti (come il caso portato in giudizio da Lawrence Lessig dimostra).
Ma il principio rimane: non sei responsabile se non hai partecipato, non hai obblighi di filtrare anche se sai che probabilmente molti dei tuoi contenuti sono stati caricati illecitamente, ma non hai una ragionevole certezza di quali essi siano. La sentenza SABAM ha dato una chiara applicazione di tale principio. Fin’ora.
Entra la riforma, entrano le lobby
La riforma, inopinatamente, introduce un sovvertimento a tale principio. Invece di darne un’interpretazione in linea con i mutati tempi, ad esempio ridefinendo il concetto di hosting e cercando di trovare un principio che distingua quando un contenuto viene caricato da un terzo, oppure è attivamente presentato invece di altri da parte di algoritmi propri della piattaforma (me ne sono occupato in tema di “autocompletamento” e “suggerimenti di ricerca”). Disapplicando in maniera radicale il principio che il gestore della piattaforma non deve monitorare e non ha responsabilità, l’art. 13 della riforma come attualmente proposto al Parlamento Europeo afferma che le piattaforme sono responsabili quando non abbiano concluso con i titolari dei diritti accordi di licenza o, in mancanza, quando non abbiano incluso nelle loro infrastrutture sistemi efficaci di filtraggio dei contenuti.
Su queste regole ci sono evidenti impronte dell’industria della discografia. Infatti questa regola è evidentemente conformata sui contenuti musicali, in cui esistono “collecting societies” (società di gestione collettiva) con le quali è possibile concludere accordi e che forniscono database di contenuti protetti da filtrare. Ma è evidente che i contenuti non si limitano solo a quelli musicali ed eventualmente cinematografici. La dissennatezza di tale principio si verifica su un importante settore dei contenuti protetti da copyright, che almeno inizialmente venne interamente sacrificato: il software, in particolare quello libero e open source, che vivono in larga parte grazie a piattaforme di condivisione dove questioni di violazione di copyright sono assai limitate in numero ed estensione.
Inoltre, un altro punto assai controverso riguarda gli “user generated content” (UGC) in generale, principalmente testi, dove il plagio è molto più “liquido” e la titolarità diffusa. Come non pensare a uno dei fenomeni più importanti a livello mondiale di tale parte dei contenuti protetti dal diritto d’autore, Wikipedia?1
Come purtroppo troppo spesso si è verificato, l’influenza dominante delle associazioni rappresentative dell’industria discografica, pur interamente legittima, ha fatto sì che la loro tutela agisse come rullo compressore su altri diritti pur altrettanto importanti se non superiori, come la libertà di espressione e la creazione di servizi innovativi su Internet.
Si introducono eccezioni
Fortunatamente nel Parlamento Europeo le assurde conseguenze che si sarebbero prodotte sono state fatte osservare, principalmente con l’attività di Julia Reda, che aveva presentato una sua relazione su cosa non funzionava nel copyright nell’era di Google (semplificando). Però, invece di adottare un principio più ragionevole, che mettesse d’accordo le opposte esigenze dei titolari dei diritti d’autore, con i titolari di altrettanto importanti diritti, primo fra tutti quello di espressione del pensiero e poi quello di libertà di impresa, si è scelta una strada diversa, molto meno equilibrata e spostata sugli interessi di alcuni a scapito di altri.
Si è scelto infatti di creare un pericolosissimo precedente, introducendo un’eccezione a una regola ‒ no duty to monitor ‒ che pure aveva dato ottimi risultati, pur con inevitabili problemi ‒ peraltro in larga parte risolti dalla giurisprudenza e dalla prassi delle autorità amministrative ‒ per accomodare le esigenze di un settore particolare (violazione industria dei contenuti). Allorché si è fatto presente che introdurre eccezioni a tale regola, oltre ad essere pericoloso in sé, crea delle conseguenze assurde e dannose, facendo degli esempi concreti, come quello del software, come quello di Wikipedia, come quello delle iniziative di conservazione delle opere (incluse quelle orfane) ai fini di preservare l’eredità culturale, si è deciso (almeno questa sembra la direzione) di aggirare le obiezioni, ma non di cambiare il metodo. Ma questi sono ovviamente solo esempi per far vedere come la regola crea disastri perché sbagliata, e gli altri prevedibili disastri di chi non si è fatto sentire?
Invece di capire che questi sono esempi di un errore fondamentale, si eliminano le obiezioni introducendo eccezioni. Ma le eccezioni a una regola si applicano solitamente ai soli casi eccezionali, i quali tendono ad essere un numero chiuso. Le eccezioni alla regola così creata sono comunque di interpretazione e applicazione restrittive. Si pensa di tacitare così coloro che hanno obiettato in maniera più radicale e che sono per fortuna fatti sentire, dando loro un contentino, così da depotenziare la loro critica.
Ciò è di gran lunga un errore di politica legislativa. La legge dovrebbe portare (pochi e buoni) principi, trattando il meno possibile casi eccezionali e specifici. Nel caso delle eccezioni, per di più evidentemente un numero chiuso di esse, si compie lo stesso errore che si è compiuto con la Direttiva 2000/31/CE, usando la dizione “hosting” anziché una più generica, come “servizi che ospitano contenuti forniti e controllati da terzi”. Nel frattempo, dopo diciotto anni, l’hosting così come era stato inteso originalmente quasi non esiste più, ci sono una serie di piattaforme di contenuti (da Facebook, al motore di ricerca di Google, a Twitter, eccetera), che rientrano nella nozione di “hosting” con molta fatica. In questo caso probabilmente è anche peggio, introducendo eccezioni limitate per fenomeni che oggi conosciamo, ma lasciando fuori fenomeni futuri, magari anche più meritevoli. O peggio, non facendoli nemmeno nascere. Con la smania di proteggere l’esistente, infatti, spesso si fa fallire l’innovazione futura. Noi non sappiamo come evolverà la tecnologia e mai lo sapremo se facciamo di tutto per privilegiare i modelli di business esistente a scapito di quelli futuri!
Le eccezioni diventano sempre più eccezionali
Fortunatamente, coloro che sono più attivi e godono di una tribuna nell’opinione pubblica, coloro che hanno puntato il riflettore dell’opinione pubblica sul problema (clamoroso l’oscuramento di Wikipedia) non si sono accontentati del boccone lanciato loro dall’emendamento di compromesso, che escludeva la parte a loro più cara dal concetto di “piattaforma di condivisione dei contenuti”. Se il principio è sbagliato, rimane sbagliato anche se alcune delle storture più evidenti vengono smussate (ma nemmeno rimosse!).
“O ci salviamo tutti, o non si salva nessuno”!
Questo è lo slogan fondamentale che guida le attività di chi fa lobbying nell’interesse pubblico, non nell’interesse particolare, contro il metodo vecchio come il mondo “Divide et impera!”. Sia Wikipedia che il mondo del software libero si rifiutano di accontentarsi, anche perché sanno che la fregatura è sempre in agguato.
Infatti, a seguito della bocciatura, per motivi più procedurali che di metodo, del testo proposto dal comitato parlamentare JURI (Giustizia) a luglio, non è che il progetto sia stato abbandonato, tutt’altro! Poiché l’iniziativa legislativa appartiene a tre istituzioni diverse (Commissione, Consiglio, Parlamento), in caso di dissenso la procedura prevede che in un dialogo (trilogo, in realtà) interistituzionale ci sia un negoziato per smussare le differenze. In questi giorni il Parlamento discuterà in sede plenaria i testi della Commissione, gli emendamenti approvati dal comitato parlamentare JURI ed eventuali nuovi emendamenti, per adottare il testo che costituirà la “proposta” Parlamento. La preoccupazione è che da più parti ci si voglia conformare al mandato che il Consiglio ha approvato come testo base della trattativa, con un testo che non necessariamente è quello, pur insufficiente, uscito dal comitato JURI e che ha visto un voto fortemente contrario a luglio, anche se tecnicamente nulla è stato deciso.
Infatti, il testo del mandato ha introdotto delle specificazioni nelle eccezioni, le quali fanno ora tutte riferimento a operatori “non profit” e al fine di lucro.
Questa precisazione fa sì che le più importanti piattaforme di condivisione, che non sono gestite da entità senza fine di lucro, né vengono necessariamente svolte senza un profitto, vengano di colpo escluse. Oltre il danno la beffa!
Per le piattaforme di sviluppo condiviso del software il fatto di menzionare “open source” è gravemente fuorviante, perché come i lettori dovrebbero ormai sapere tale accezione viene data (e tolta!) dalla licenza applicata al software. Il quale potrebbe contenere ad esempio parti di codice proprietario (“open core”), oppure venire offerto anche in versione libera (“dual licensing”). In generale, introdurre condizioni e specificazioni a un’eccezione significa renderla ancora più restrittiva. Far sì che l’operatore debba essere non profit e la piattaforma in sé gratuita non ha alcun senso, visto che tra l’altro le piattaforme più popolari non rispondono a quei requisiti, mentre svolgono ‒ piaccia o no ai puristi ‒ una funzione importante nell’ecosistema del software.
Pertanto, gli attori delle libertà digitali si stanno impegnando, se possibile, a rimuovere l’insensatezza di un articolo 13 che solo apparentemente ha risolto le proprie contraddizioni. Se non possibile, almeno a limitare i danni eliminando le storture più gravi eliminando le specificazioni introdotte nelle eccezioni.
Sembra una battaglia di retroguardia e molto tecnica, di lana caprina. In realtà, come spesso accade, soprattutto nel diritto, il Diavolo si annida nei dettagli. Poche parole aggiunte sapientemente, un aggettivo, un avverbio, un sostantivo malizioso è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Che in questo caso è un vero e proprio vaso di Pandora.
L’articolo 13, se deve essere come è stato proposto, deve sparire.
1Wikimedia Italia e Wikimedia Foundation sono e sono stati, rispettivamente, assistiti dall’autore.







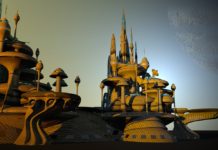


Facebook Comments