“Oltre che di una Smart City, abbiamo bisogno di uno Smart Planning, cioè di una progettazione, di una pianificazione, di politiche che siano più intelligenti. Il che significa che devono diventare più “smart” anche la PA e i sistemi produttivi”.
È quanto afferma Maurizio Carta, professore di Urbanistica e Pianificazione territoriale presso l’Università di Palermo e socio fondatore del Digital Transformation Insititute, durante una “chiacchierata” intorno al tema delle città intelligenti e dei progetti attivi in Italia finalizzata a costruire la ricerca Smart Cities: quali impatti sulle città del futuro?
Quali gli elementi ostativi in un progetto di Smart City?
Finora abbiamo lavorato sulle protesi tecnologiche delle città, senza intervenire nella struttura della città. Mi spiego meglio: abbiamo ritenuto, prendendo in prestito la retorica e i protocolli delle Smart City delle città europee, che bastasse lavorare soltanto sulla dimensione tecnologica, della partecipazione, piuttosto che dei sensori. Ovviamente fondamentali, ma le nostre città, soprattutto le città italiane, mediterranee, hanno bisogno che questa trasformazione avvenga fin dal modo in cui sono pensate, progettate, gestite.
La necessità è quella di lavorare su una pianificazione a progettazione intelligente della città, che ripensi il modo in cui ci muoviamo in maniera radicale, che ripensi anche alle nostre stesse forme dell’insediamento.
La via italiana è quella di rimettere mano in maniera radicale al modello di città, recuperando il nostro modello più tradizionale. Le città italiane così come si sono configurate tra la fine del e il Rinascimento, erano intelligenti per natura, basterebbe guardare l’affresco sul Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti per avere tutte le componenti della città intelligente: il rapporto con il paesaggio, la presenza della produzione (che non può essere espulsa dalle città), il raccordo tra diverse classi sociali, il decoro e la sicurezza. Dovremmo recuperare la nostra migliore tradizione urbana, ovviamente utilizzando la tecnologia come un acceleratore, un dispositivo abilitante di intelligenza collettiva.
Intende un attivatore di processi?
Sì, diventa attivatore nel momento in cui c’è un protocollo che permette l’attivazione di nuove modalità imperative/interattive. Se i nostri strumenti urbanistici (che sono quelli che generano lo sviluppo città) sono ancora attivi di un approccio puramente regolativo, puramente basato sulla rendita, non c’è tecnologia che possa attivare nulla.
Se volessimo citare casi di successo e fallimento nei progetti Smart City?
Non credo si possa parlare di fallimento, perché non possiamo non riconoscere alcune esperienze interessanti. Il problema è che c’è un disallineamento tra i risultati conseguiti nella dimensione tipica delle Smart City (la dimensione dell’innovazione tecnologica, la dimensione dell’efficienza energetica) e l’innovazione non altrettanto simultanea e rapida che avviene nelle forme più complessive di progettazione della città. Non possiamo non pensare, ad esempio, che una città intelligente è una città che ricicla il patrimonio sottoutilizzato. Questo però non è aiutato da nessun provvedimento perché, oggi, gli strumenti urbanistici non premiano, non agevolano chi vuole riciclare aree o infrastrutture.
Che ruolo deve avere la PA?
Il ruolo della PA andrebbe ridisegnato per vari motivi, alcuni contingenti l’azzeramento delle risorse pubbliche, altri che fanno parte di uno spirito del tempo, aventi a che fare, quindi, con la necessità di una maggiore interazione tra pubblico, privato e società civile.
Va ripensato il ragionamento sulla governance delle città contemporanee, soprattutto delle città italiane ma soprattutto vanno sperimentate forme di cooperazione più attive tra pubblico, privato e società civile. Perché nel momento in cui viene chiamata la popolazione, non soltanto a segnalare problemi, ma a farsi carico di una parte della risoluzione, cambia il rapporto e il patto costitutivo tra amministrazione e cittadini e cambiano anche le forme del progetto.
Nell’era della Digital Transformation, non ci possono essere soggetti che non vivono questa metamorfosi e non cambiano i loro meccanismi.
Come pensiamo di agevolare l’Intelligenza Urbana, che è essenzialmente connessione, integrazione quando poi le Amministrazioni continuano a lavorare per settori separati? La vera intelligenza, la vera smartness urbana è integrazione. L’integrazione, però, non può essere soltanto dichiarata e poi nella quotidianità non produrre risultati concreti.
Quindi l’elemento più importante è il coinvolgimento dei cittadini?
Secondo me è l’elemento fondamentale, ma non solo nel momento decisionale, anche nel momento progettuale, nel momento gestionale, nel momento valutativo. Un po’ come il concetto di Open Source che sempre più spesso utilizziamo. In un modello Open Source so che sto mettendo in territorio un modello urbanistico incompleto, ma volutamente incompleto e chiedo agli utilizzatori/cittadini di completarlo e restituirmelo. Il piano diventa una sorte di learning machine, dove impara e arricchisce.
Cosa dire rispetto al tema degli investimenti che ostacolano lo sviluppo?
Un vero investimento dovrebbe avere una capacità di produrre un profitto, un ritorno, un rendimento sociale molto più ampio. Finché i rendimenti saranno immediati c’è il rischio che le sperimentazione siano locali ed estemporanee. Bisogna avere la certezza che gli investimenti siano protetti da amministrazioni locali stabili e che non vengano resi vani anche nel momento di passaggio da un’amministrazione all’altra. Solo in questo modo è possibile garantire piani a lungo termine. E dov’è che abbiamo bisogno di maggiori investimenti? Nelle zone più delicate. Le città, le periferie, i comuni di media cintura, perché se continuiamo a fare sperimentazioni di Smart City soltanto nelle grandi città, non cambiamo l’intelligenza della struttura urbana del Paese.
Il rischio è che difficilmente le amministrazioni si impegnano in una sfida del genere. C’è sempre, a mio parere, un accordo tra l’interesse privato e l’interesse pubblico.
Quale il problema di gestione in Italia?
Secondo me la PA ha raggiunto il massimo possibile del risultato in quella stagione nata nei primi anni ’90 con i programmi urban, in cui si è fatta davvero un’operazione di capacity building notevole.
Ora, però, la PA deve fare un salto ulteriore e promuovere non più solo un’integrazione che tra settori e amministrazione, ma un’integrazione tra settori, amministrazione e soggetti esterni. Ovviamente tra i soggetti esterni metto anche l’Università perché vuol dire riattivare quel rapporto tra Università, Città, PA, perché permette alla ricerca scientifica di trasferirsi immediatamente nel terreno istituzionale e permette alla dimensione istituzionale di dotarsi collaboratori che lavorano abitualmente su queste materie.
Come siamo messi invece a Open Data?
C’è un problema soprattutto per quanto concerne la trasparenza. Spesso vengono spacciati come Open Data, ma sono al massimo delle informazioni semi giornalistiche. Secondo me il problema è sempre lo stesso: si comprende che sono importanti, ma il rischio è che ancora non siano visti gli effetti di cosa significa poter decidere in presenza di un sistema veramente aperto e collaborativo di Open Data e in sua assenza. Gli esperimenti che sta facendo Amsterdam con delle piattaforme online attraverso cui chiunque può vedere in tempo reale l’andamento delle condizioni ambientali della città, o l’esperimento di Boston che fa diventare i cittadini produttori di dati. Ecco questi sono esperimenti che hanno dimostrato che c’è, quantomeno, un risparmio di costi negli interventi.






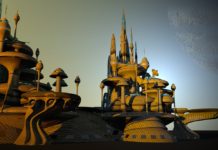



Facebook Comments